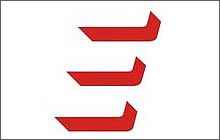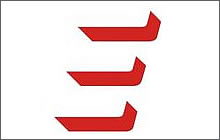Galbiate: la signora Pierina Borroni festeggia il 100° in Rsa
Grande festa nella giornata di domenica 8 febbraio presso la RSA Villa Serena di Galbiate, dove la signora Pierina Borroni, ospite della struttura, ha festeggiato la bellezza di 100 anni. Lo staff e altri ospiti si sono uniti ai festeggiamenti, e con loro anche i familiari e tanti amici della signora Pierina. Hanno raggiunto la Rsa per l’occasione anche il sindaco di Airuno Gianfranco Lavelli e l’assessore Adele Gatti.

Di seguito le parole della signora Piera Borroni stessa, che in occasione del centenario, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita.

“Avevo studiato fino alla quinta elementare e poi ho aspettato fino a quattordici anni il libretto per poter lavorare. Mi avevano subito assunto al cotonificio Cantoni di Bellano ma ogni 4/5 mesi chiudevano e poi riaprivano e sono andati avanti così fino al 1943 dove lo stabilimento chiuse definitivamente per la guerra.
Per qualche tempo sono andata a servizio a Milano presso una famiglia facoltosa che passava l’inverno a Rapallo.
Da loro facevo le pulizie e aiutavo in cucina e mi volevano bene. Di ritorno a Milano i signori ormai anziani si sono ritirati in una casa di assistenza e sono rimasta senza lavoro. Avevo 17 anni.

Tornata a casa mi arrangiavo lavorando qua e là a servizio.
Una infermiera di Milano, che veniva tutti gli anni da noi in villeggiatura e che conoscevo da ragazzina, aveva proposto a me e a una mia sorella di andare a lavorare in ospedale perché c’era tanto bisogno. Mia sorella non se l’è sentita mentre io e una mia cara amica di nome Elide abbiamo accettato. Qualche soldo in più in famiglia era d’aiuto.
A diciotto anni ho iniziato a lavorare come aiutante infermiera all’ospedale Niguarda di Milano, era il 1944 ed eravamo in piena guerra.
Mia mamma era preoccupata per la scelta di andare a Milano ma la fame e le necessità hanno scelto per noi.

Al lavoro indossavo una divisa bianca con la gonna, la cuffietta in testa e ai piedi quello che si aveva perché in quegli anni difficili non si trovava niente.
Durante il turno mi occupavo dei letti, svuotavo le padelle, facevo l’igiene agli ammalati, servivo il pranzo e pulivo i pavimenti.
Qualche mese dopo la mia assunzione era arrivato presso l’ospedale un ferito grave: si vociferava che era il capo dei partigiani. Era ricoverato in un’ala dell’ospedale sorvegliato dai soldati tedeschi giorno e notte.
Le suore e i dottori di quel reparto si prodigavano per non farlo guarire e per far sembrare le sue condizioni sempre peggiori affinchè non potessero interrogarlo, torturalo o fucilarlo.
Giravano voci tra noi italiani che quando questo uomo fosse sparito dall’ospedale ci sarebbe stata la liberazione. All’ospedale arrivavano in continuazione camionette con la bandiera rossa piena di feriti: soldati italiani, tedeschi, civili e una volta scaricati venivano trasportati e divisi nei vari reparti.

Il personale disponibile correva per tutti avanti e indietro, non si guardava chi fossero perchè tutti venivano assistiti.
Durante il lavoro all’interno dell’ospedale si sentivano spesso bombardamenti anche molto vicino e spesso si vedeva ronzare sopra di noi un piccolo aereo che tutti chiamavano: “Pippo” che bombardava la gente per strada e spesso anche il tram pieno di persone che si recavano all’ospedale.
Un giorno mentre lavoravamo suonò l’allarme e quando questo succedeva avevamo l’ordine di recarci il più velocemente possibile nei sotterranei dei vari padiglioni che utilizzavamo come rifugio. Si trasportavano anche i feriti e gli ammalati in un fuggi fuggi generale dove tutti aiutavano tutti come si poteva. Nel rifugio si pregava, si piangeva e si battezzavano i bambini appena nati perché se fossero morti lo sarebbero stati in grazia di Dio.

In quella occasione che non dimenticherò mai cadde una bomba sul reparto maternità. La bomba fortunatamente rimase inesplosa perché sarebbe stata una strage. Finito il pericolo siamo andati a vedere l’immensa voragine creata in mezzo al padiglione con la bomba tutta intera coperta da detriti.
Le infermiere che lavoravano all’ospedale in quegli anni di guerra vivevano in un piano attrezzato come dormitorio perché era impossibile tornare a casa. Solo il giorno libero ci si poteva allontanare e uscire con un permesso.
La mia famiglia abitava in alta Valsassina in un paesino chiamato Indovero una frazione di Casargo. Mio papà Antonio lavorava alla FALC a Sesto S. Giovanni e anche lui tornava a casa solo il sabato e la domenica. Mia mamma Maria Piatti si occupava della casa dei figli delle bestie e dei campi. Le mie sorelle: Giovanna del 1922, Maria del 1923, Adele del 1924 aiutavano come potevano mentre Giuditta l’ultima delle sorelle del 1928 che era di salute cagionevole aiutava in casa. Poi c’erano Carlo del 1934 e Angelo del 1935 che erano piccolini. Erano nate anche Zelinda nel 1938 e Margherita nel 1941 ma erano morte dopo pochi mesi di vita.
Tenevamo due mucche, capre, un maiale, galline e conigli e qualche volta era capitato che i fascisti ci portassero via la roba.

Una mattina suor Maddalena prima di darci le direttive controllò dal balcone la situazione del partigiano perché si aspettava che succedesse qualcosa. Io e un’altra collega siamo uscite a stendere un golf rosso e la suora ce lo fece togliere subito. Nello stesso momento dall’ingresso principale entrarono delle camionette con una bandiera rossa e in ogni dove c’era agitazione perché quelle vetture erano piene di feriti.
Nella confusione generale correvano tutti e in quel trambusto sparì anche il partigiano. Il Duce veniva catturato a Dongo.
Dopo tre o quattro giorni in libera uscita e in compagnia, siamo andate in centro per vedere anche noi il Duce appeso a testa in giù con la Petacci e Starace e qualche altro appeso come si faceva con i maiali.
Mentre percorrevamo una via che conduceva a Piazza Loreto aumentavano le persone che si recavano li per lo stesso motivo e ad un certo punto cominciò a tremare sotto i piedi il pavimento.
Dietro di noi stavano arrivando dei carri armati con i soldati americani. Al loro passaggio lanciavano caramelle, cioccolato, sigarette, calze di nylon. Sembrava piovesse e la gente si spintonava per correre e arraffare tutto quello che riusciva. I soldati hanno tolto i cadaveri da dove erano appesi per portarli via. La gente era in processione per sputargli addosso e qualcuno prima che li togliessero aveva sparato colpi sui cadaveri appesi.

Successe tutto così in fretta che eravamo cosi spaventate da scappare e tornare di corsa all’ospedale senza raccogliere niente di tutto quello che gli americani avevano lanciato alla gente.
Di li a poco il cotonificio a Bellano fu riaperto e sono tornata a casa dove ci siamo ritrovati con tutta la famiglia e mio papà ci ha raccontato che dove lavorava non hanno mai bombardato perché li facevano le armi. La loro azienda aveva convertito la produzione per la guerra.
Prima di andare a Milano avevo simpatie per un mio compaesano di nome Bortolo e ci eravamo promessi di ritrovarci dopo la guerra. Lui prima di partire al fronte mi aveva chiesto di aspettarlo ma un destino crudele lo ha fermato in Russia durante una battaglia.
A fine guerra quando non l’ho visto tornare abbiamo saputo che era stato dichiarato disperso.
Suo fratello voleva sposarmi ma non ho avuto la forza di accettare, gli assomigliava tanto.
Dopo sette anni ho incontrato Emilio Tagliaferri di Pagnona vedovo con due figli ma viveva ad Airuno.
Ogni tanto ci si rincontrava e il destino volle che ci innamorammo.
L’ho sposato nel 1960 il 15 ottobre e mi sono trasferita con lui ad Airuno. Un figlio Franco aveva 12 anni e l’altro Raffaele 10. Dal nostro matrimonio sono nati Maria Teresa nel 1962 ma morì subito dopo il parto, poi nel 1963 Bruno e nel 1964 Fabio. Ci siamo voluto tutti bene e siamo stati felici.
Ho 9 nipoti, sono bisnonna e non rimpiango niente della mia vita."

Di seguito le parole della signora Piera Borroni stessa, che in occasione del centenario, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita.

“Avevo studiato fino alla quinta elementare e poi ho aspettato fino a quattordici anni il libretto per poter lavorare. Mi avevano subito assunto al cotonificio Cantoni di Bellano ma ogni 4/5 mesi chiudevano e poi riaprivano e sono andati avanti così fino al 1943 dove lo stabilimento chiuse definitivamente per la guerra.
Per qualche tempo sono andata a servizio a Milano presso una famiglia facoltosa che passava l’inverno a Rapallo.
Da loro facevo le pulizie e aiutavo in cucina e mi volevano bene. Di ritorno a Milano i signori ormai anziani si sono ritirati in una casa di assistenza e sono rimasta senza lavoro. Avevo 17 anni.

Tornata a casa mi arrangiavo lavorando qua e là a servizio.
Una infermiera di Milano, che veniva tutti gli anni da noi in villeggiatura e che conoscevo da ragazzina, aveva proposto a me e a una mia sorella di andare a lavorare in ospedale perché c’era tanto bisogno. Mia sorella non se l’è sentita mentre io e una mia cara amica di nome Elide abbiamo accettato. Qualche soldo in più in famiglia era d’aiuto.
A diciotto anni ho iniziato a lavorare come aiutante infermiera all’ospedale Niguarda di Milano, era il 1944 ed eravamo in piena guerra.
Mia mamma era preoccupata per la scelta di andare a Milano ma la fame e le necessità hanno scelto per noi.

Al lavoro indossavo una divisa bianca con la gonna, la cuffietta in testa e ai piedi quello che si aveva perché in quegli anni difficili non si trovava niente.
Durante il turno mi occupavo dei letti, svuotavo le padelle, facevo l’igiene agli ammalati, servivo il pranzo e pulivo i pavimenti.
Qualche mese dopo la mia assunzione era arrivato presso l’ospedale un ferito grave: si vociferava che era il capo dei partigiani. Era ricoverato in un’ala dell’ospedale sorvegliato dai soldati tedeschi giorno e notte.
Le suore e i dottori di quel reparto si prodigavano per non farlo guarire e per far sembrare le sue condizioni sempre peggiori affinchè non potessero interrogarlo, torturalo o fucilarlo.
Giravano voci tra noi italiani che quando questo uomo fosse sparito dall’ospedale ci sarebbe stata la liberazione. All’ospedale arrivavano in continuazione camionette con la bandiera rossa piena di feriti: soldati italiani, tedeschi, civili e una volta scaricati venivano trasportati e divisi nei vari reparti.

Il personale disponibile correva per tutti avanti e indietro, non si guardava chi fossero perchè tutti venivano assistiti.
Durante il lavoro all’interno dell’ospedale si sentivano spesso bombardamenti anche molto vicino e spesso si vedeva ronzare sopra di noi un piccolo aereo che tutti chiamavano: “Pippo” che bombardava la gente per strada e spesso anche il tram pieno di persone che si recavano all’ospedale.
Un giorno mentre lavoravamo suonò l’allarme e quando questo succedeva avevamo l’ordine di recarci il più velocemente possibile nei sotterranei dei vari padiglioni che utilizzavamo come rifugio. Si trasportavano anche i feriti e gli ammalati in un fuggi fuggi generale dove tutti aiutavano tutti come si poteva. Nel rifugio si pregava, si piangeva e si battezzavano i bambini appena nati perché se fossero morti lo sarebbero stati in grazia di Dio.

In quella occasione che non dimenticherò mai cadde una bomba sul reparto maternità. La bomba fortunatamente rimase inesplosa perché sarebbe stata una strage. Finito il pericolo siamo andati a vedere l’immensa voragine creata in mezzo al padiglione con la bomba tutta intera coperta da detriti.
Le infermiere che lavoravano all’ospedale in quegli anni di guerra vivevano in un piano attrezzato come dormitorio perché era impossibile tornare a casa. Solo il giorno libero ci si poteva allontanare e uscire con un permesso.
La mia famiglia abitava in alta Valsassina in un paesino chiamato Indovero una frazione di Casargo. Mio papà Antonio lavorava alla FALC a Sesto S. Giovanni e anche lui tornava a casa solo il sabato e la domenica. Mia mamma Maria Piatti si occupava della casa dei figli delle bestie e dei campi. Le mie sorelle: Giovanna del 1922, Maria del 1923, Adele del 1924 aiutavano come potevano mentre Giuditta l’ultima delle sorelle del 1928 che era di salute cagionevole aiutava in casa. Poi c’erano Carlo del 1934 e Angelo del 1935 che erano piccolini. Erano nate anche Zelinda nel 1938 e Margherita nel 1941 ma erano morte dopo pochi mesi di vita.
Tenevamo due mucche, capre, un maiale, galline e conigli e qualche volta era capitato che i fascisti ci portassero via la roba.

Una mattina suor Maddalena prima di darci le direttive controllò dal balcone la situazione del partigiano perché si aspettava che succedesse qualcosa. Io e un’altra collega siamo uscite a stendere un golf rosso e la suora ce lo fece togliere subito. Nello stesso momento dall’ingresso principale entrarono delle camionette con una bandiera rossa e in ogni dove c’era agitazione perché quelle vetture erano piene di feriti.
Nella confusione generale correvano tutti e in quel trambusto sparì anche il partigiano. Il Duce veniva catturato a Dongo.
Dopo tre o quattro giorni in libera uscita e in compagnia, siamo andate in centro per vedere anche noi il Duce appeso a testa in giù con la Petacci e Starace e qualche altro appeso come si faceva con i maiali.
Mentre percorrevamo una via che conduceva a Piazza Loreto aumentavano le persone che si recavano li per lo stesso motivo e ad un certo punto cominciò a tremare sotto i piedi il pavimento.
Dietro di noi stavano arrivando dei carri armati con i soldati americani. Al loro passaggio lanciavano caramelle, cioccolato, sigarette, calze di nylon. Sembrava piovesse e la gente si spintonava per correre e arraffare tutto quello che riusciva. I soldati hanno tolto i cadaveri da dove erano appesi per portarli via. La gente era in processione per sputargli addosso e qualcuno prima che li togliessero aveva sparato colpi sui cadaveri appesi.

Successe tutto così in fretta che eravamo cosi spaventate da scappare e tornare di corsa all’ospedale senza raccogliere niente di tutto quello che gli americani avevano lanciato alla gente.
Di li a poco il cotonificio a Bellano fu riaperto e sono tornata a casa dove ci siamo ritrovati con tutta la famiglia e mio papà ci ha raccontato che dove lavorava non hanno mai bombardato perché li facevano le armi. La loro azienda aveva convertito la produzione per la guerra.
Prima di andare a Milano avevo simpatie per un mio compaesano di nome Bortolo e ci eravamo promessi di ritrovarci dopo la guerra. Lui prima di partire al fronte mi aveva chiesto di aspettarlo ma un destino crudele lo ha fermato in Russia durante una battaglia.
A fine guerra quando non l’ho visto tornare abbiamo saputo che era stato dichiarato disperso.
Dopo sette anni ho incontrato Emilio Tagliaferri di Pagnona vedovo con due figli ma viveva ad Airuno.
Ogni tanto ci si rincontrava e il destino volle che ci innamorammo.
L’ho sposato nel 1960 il 15 ottobre e mi sono trasferita con lui ad Airuno. Un figlio Franco aveva 12 anni e l’altro Raffaele 10. Dal nostro matrimonio sono nati Maria Teresa nel 1962 ma morì subito dopo il parto, poi nel 1963 Bruno e nel 1964 Fabio. Ci siamo voluto tutti bene e siamo stati felici.
Ho 9 nipoti, sono bisnonna e non rimpiango niente della mia vita."