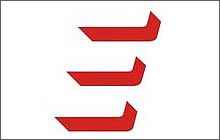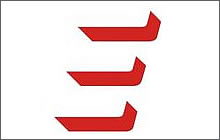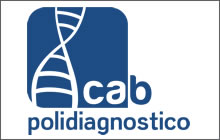SCAFFALE LECCHESE/246: L’assistenza ospedaliera nel Lecchese dal ‘700 ad oggi
In questi giorni, l’ospedale “Manzoni” di Lecco ha festeggiato i 25 anni. Un quarto di secolo in cui molte cose sono cambiate. Oggi addirittura ci chiediamo se il futuro ci garantirà ancora una sanità davvero pubblica. Concetto, quello dell’assistenza sanitaria ai meno abbienti come dovere collettivo, che cominciò a prendere seriamente forma tra Ottocento e Novecento e che fu possibile grazie a lasciti e donazioni di personaggi facoltosi. Altri tempi! 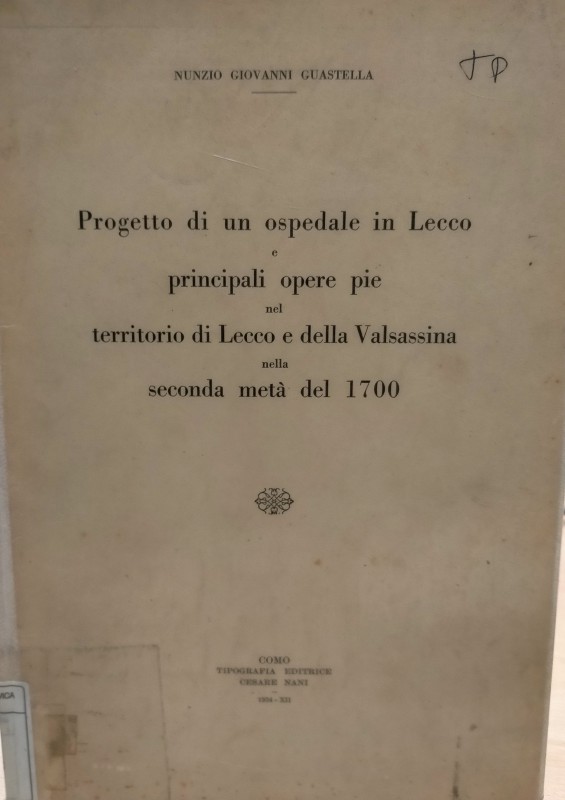 Ancora nel Settecento «molte comunità di Lecco e della Valsassina reputavano già inutili e superflue le spese per i medici condotti». Così scriveva lo storico milanese, ma con assidue frequentazioni lecchesi, Nunzio Giovanni Guastella (1882-1953) in uno studio pubblicato nel 1934, prima sul Periodico della Società storica comense e poi come estratto in un volumetto stampato dall’Editrice comasca Cesare Nani: “Progetto di un ospedale in Lecco e principali opere pie nel territorio di Lecco e della Valsassina nella seconda metà del 1700”. Per esempio, Guastella ricordava che, quando nel 1749, il governo centrale (austriaco) aumentò le tasse, «le comunità oberate dai debiti corsero ai ripari eliminando le spese superflue. Le comunità del territorio di Lecco posero tra le spese non strettamente necessarie e inderogabili le poche centinaia di lire che davano ai medici condotti, sicché il servizio sanitario per i poveri fu completamente abolito». Del resto, i poveri «più che di medici e medicine avevan bisogno di alimenti. E forse proprio per questo motivo le opere pie del territorio avevano mirato specialmente alla assistenza alimentare, riservando qualche tenuissimo residuo a quella sanitaria».
Ancora nel Settecento «molte comunità di Lecco e della Valsassina reputavano già inutili e superflue le spese per i medici condotti». Così scriveva lo storico milanese, ma con assidue frequentazioni lecchesi, Nunzio Giovanni Guastella (1882-1953) in uno studio pubblicato nel 1934, prima sul Periodico della Società storica comense e poi come estratto in un volumetto stampato dall’Editrice comasca Cesare Nani: “Progetto di un ospedale in Lecco e principali opere pie nel territorio di Lecco e della Valsassina nella seconda metà del 1700”. Per esempio, Guastella ricordava che, quando nel 1749, il governo centrale (austriaco) aumentò le tasse, «le comunità oberate dai debiti corsero ai ripari eliminando le spese superflue. Le comunità del territorio di Lecco posero tra le spese non strettamente necessarie e inderogabili le poche centinaia di lire che davano ai medici condotti, sicché il servizio sanitario per i poveri fu completamente abolito». Del resto, i poveri «più che di medici e medicine avevan bisogno di alimenti. E forse proprio per questo motivo le opere pie del territorio avevano mirato specialmente alla assistenza alimentare, riservando qualche tenuissimo residuo a quella sanitaria».
Assodato che i benestanti si curavano, guarivano o morivano, nel proprio letto, a lungo l’assistenza ai poveri era stata più un sostegno contro l’indigenza che un’assistenza sanitaria vera e propria. Ma il legame tra malattia e indigenza era comunque stretto. Quando la malattia costringeva all’inabilità e impediva quindi di svolgere un mestiere si spalancavano spesso le porte della miseria assoluta.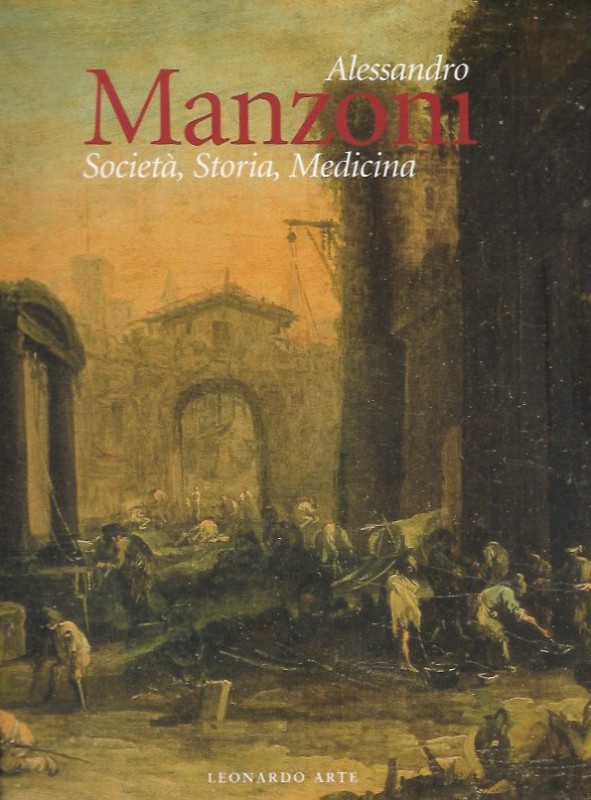 Lo spiega Mauro Rossetto, conservatore dei musei lecchesi: «Drammatica era la situazione degli anziani anche se in precedenza avevano esercitato un lavoro: nel momento in cui diventavano inabili fisicamente o (nel caso delle donne) cadevano nella vedovanza e non erano sostenuti dall’inserimento in un nucleo familiare, piombavano immediatamente nella totale miseria ed avevano l’accattonaggio o le elemosine della carità pubblica come unica risorsa».
Lo spiega Mauro Rossetto, conservatore dei musei lecchesi: «Drammatica era la situazione degli anziani anche se in precedenza avevano esercitato un lavoro: nel momento in cui diventavano inabili fisicamente o (nel caso delle donne) cadevano nella vedovanza e non erano sostenuti dall’inserimento in un nucleo familiare, piombavano immediatamente nella totale miseria ed avevano l’accattonaggio o le elemosine della carità pubblica come unica risorsa».
Leggiamo queste parole in un volume, curato dall’allora direttore museale Gianluigi Daccò e dallo stesso Rossetto, uscito nel 2000 proprio in occasione dell’inaugurazione dell’ospedale dell’Eremo: “Alessandro Manzoni. Società, storia, medicina”. Fu pubblicato con l’editrice “Leonardo Arte” dalla stessa azienda ospedaliera quale dimostrazione che la scelta di intitolare la struttura a Manzoni non fosse campata per aria, il solito banale tributo cittadino, l’ennesimo, all’autore dei “Promessi sposi”.
Anni dopo, nel 2007, lo stesso ospedale avrebbe pubblicato un agile libretto su “L’assistenza ospedaliera nel territorio di Lecco. Storia civica di un impegno civile e umanitario” con testi di Gianfranco Scotti a sintetizzare la storia dei tre presidi pubblici ospedalieri sopravvissuti del Lecchese (Lecco, Merate e Bellano) e un intervento del progettista dell’ospedale “Manzoni”, Aurelio Gorgerino.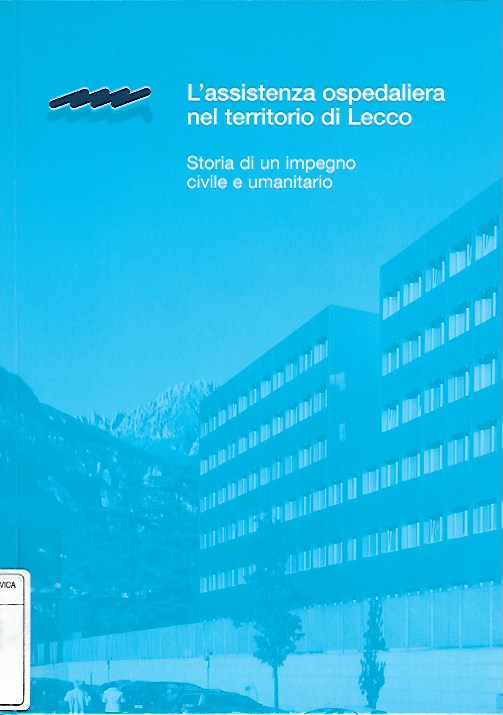 A lungo, il confine tra ricovero per indigenti o per malati è stato spesso incerto, a volte inesistente, a volte arbitrario.
A lungo, il confine tra ricovero per indigenti o per malati è stato spesso incerto, a volte inesistente, a volte arbitrario.
Del resto, in origine era “hospitale”, parola che indicava un tetto per i poveri, ma anche per i pellegrini o i semplici viaggiatori. Ospitale, per esempio, è una località dei Piani d’Erna, dove probabilmente esisteva un punto di appoggio per chi percorreva le strade che collegavano Lecco con la Bergamasca o la Valsassina attraverso Morterone. E’ appunto nell’Ottocento che la differenza si delinea con maggiore evidenza: i ricoveri assistenziali cominciano a evolvere lungo il percorso che arriverà agli ospizi per i poveri e a quelle che oggi sono le rsa (residenze sanitarie assistenziali), mentre sul fronte sanitario sorgono gli ospedali secondo l’accezione moderna.
L’assistenza e la cura erano sempre state sostenute dalla beneficenza e se ne occupavano opere pie e confraternite. Proprio Guastella ne ha catalogate una ventina tra Lecco e la Valsassina: a Lecco, per esempio esisteva, tra le altre, una Scuola dei vivi e dei morti fondata a cavallo tra Cinque e Seicento e che, tra le varie attività. amministrò anche il lazzaretto allestito per la peste “manzoniana” del 1630.
Il primo autentico mattone per un ospedale lecchese fu quello che è ricordato come il lascito Pagani e si risale addirittura al Settecento. Si tratta del testamento redatto il 19 maggio 1741 dall’allora parroco di Acquate Giovanni Battista Pagani (morto nel 1768) con il quale si disponeva «che gran parte delle sue sostanze fosse utilizzata allo scopo di istituire un ospedale per il ricovero e la cura degli infermi e poveri di Lecco»: ce ne parla diffusamente Paola Tettamanzi in “Due secoli di vita ospedaliera a Lecco (1741-1930)”, numero monografico della rivista storica “Archivi di Lecco” (il 4 del 1987).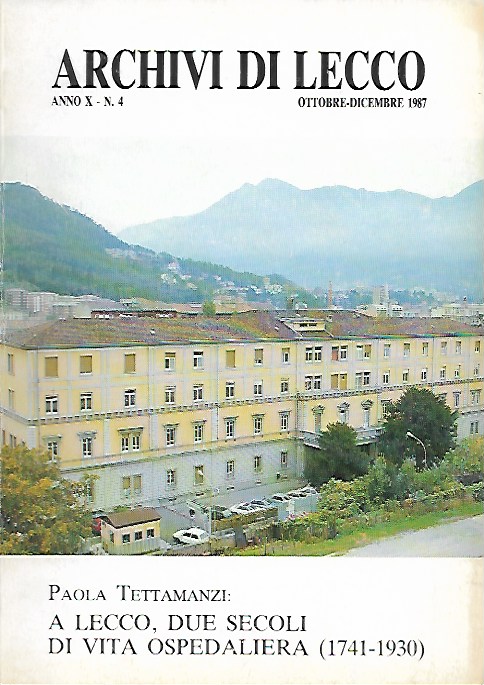 Per tutta una serie di motivi, non ultime le volontà del defunto impugnate da un erede, il lascito restò a lungo congelato.
Per tutta una serie di motivi, non ultime le volontà del defunto impugnate da un erede, il lascito restò a lungo congelato.
«La necessità di un luogo per la cura – scrive Rossetto – tornò alla ribalta nel 1785, quando il patriziato del territorio lecchese e della Valsassina avanzò una supplica all’imperatore perché fosse eretto un ospedale in città» proponendo di raccogliere i fondi unendo diverse rendite: quelle del Luogo Pio per vecchi impotenti di Lecco, dei soppressi monasteri di San Giacomo a Castello di Lecco e del Cantello in Valsassina e di quell’ospedale di Acquate, realizzato due secoli prima grazie al lascito testamentario del nobile Giovanni Antonio Airoldi, struttura che raccoglieva poveri ma non ammalati e che è la radice prima di quell’Istituto Airoldi-Muzzi di cui si dovrà tornare a parlare. Oltre, naturalmente al già menzionato “lascito Pagani”. «La risposta imperiale non tardò ad arrivare – scrive sempre Rossetto -: con il reale dispaccio del 16 settembre 1785, infatti, venne accordata l’erezione dell’ospedale tanto desiderato assegnando a tale scopo il fabbricato del soppresso monastero di monache di Castello sopra Lecco, situato in aria salubre, ed ove si trovano Medici, Chirurghi e Spezierie». Che fossero i lecchesi, però, a darsi da fare per recuperare i fondi necessari. Fondi che però non vennero trovati a sufficienza e per circa mezzo secolo non se ne fece nulla.
Si dovrà attendere il 1830, quando il ricco possidente lecchese Antonio Muzzi donò ai Luoghi Pii Elemosinari di Lecco la cifra di ventimila lire per la costruzione di un civico ospedale. Amministratore dei Luoghi Pii era don Vittorino Cremona, tra l’altro zio dello scrittore Antonio Ghislanzoni per via materna. E don Vittorino si attivò. Naturalmente non mancarono intralci di varia natura che ritardarono i lavori. Scrive Gianfranco Scotti: «L’articolata vicenda riprende il suo corso con la morte del Muzzi, nel 1837. Due anni prima, egli aveva donato ulteriori ventimila lire milanesi, confidando nella generosità dei suoi concittadini al fine di completare l’erezione dell’ospedale. I lavori spesso interrotti per mancanza di fondi, erano iniziati nel 1836 su progetto di Giuseppe Bovara, figura luminosa nel panorama sociale e culturale dell’Ottocento lecchese. (…) Non solo non pretese di venire ricompensato per il lavoro di progettista, ma addirittura mise a disposizione 3200 lire milanesi del suo patrimonio personale per gli ultimi dieci pilastri del cortile porticato. Il 18 giugno 1843, il nuovo edificio, di nobili quanto sobrie linee neoclassiche, venne inaugurato. Ma il progetto dell’architetto lecchese fu realizzato per un solo quarto, nonostante il generoso lascito del Muzzi».
«Il 7 agosto 1843 – ci racconta Paola Tettamanzi – si ospitò il primo degente, l’ottuagenaria Rosalinda Bignetti vedova Invernizzi, di Lecco, affetta da forte febbre reumatica. Il ricovero fu dovuto alla pietà nei confronti della vecchia che mancava di ogni mezzo per l’assistenza e sollecitato dal fatto che alcuni lontani parenti si erano offerti di pagare la quota giornaliera. (…) Al termine del 1843, il bilancio statistico confermava l’avvenuto ricovero di quindici malati, tra i quali alcuni paganti e due militari. Cinque furono i decessi, tra i quali tre di tisichezza avanzata. Ordinariamente, in ciascun giorno non si trovavano nel pio luogo che due, tre o al più quattro malati. (…) I ricoverati fino all’anno 1847 si aggirano intorno ad una media di circa 40 malati all’anno. La punta raggiunta nel 1847 è correlata alle misere condizioni alimentari in un anno in cui “per le ingenti richieste di granaglie fatte specialmente dalla Svizzera, veniva quasi quintuplicato il prezzo del pane, della pasta e della farina di polenta”».
Il racconto di Tettamanzi ci avvicina anche all’evoluzione della medicina, alle credenze popolari, alle innovazioni più o meno serie come la catena elettrogena del dottor Wood che assicurava la guarigione senza medicine di tutte le malattie umane.
Proprio accanto all’ospedale, tra l’altro, nel 1863 venne realizzata la stazione ferroviaria. Avrebbe scritto il giornalista Uberto Pozzoli, in un articolo del 1925: «Con treni di notte e di giorno, coi fischi, col tin tan dei respingenti e con le bestemmie dei facchini, gli ammalati non avevano tanto da scegliere: o tornare a casa o andare al manicomio. Fu così che, nella quaresima del 1893, si decise di costruire un nuovo ospedale nelle vicine del Colombaio» come si chiamava una zona di Pescarenico.
Si cominciò dunque prima della fine del XIX secolo a prefigurare il nuovo ospedale lecchese che è poi quello durato un secolo, con ampliamenti e nuovi padiglioni, sulla strada poi intitolata a Ghislanzoni. Si costruì tra 1899 e 1900. «Le aspettative della popolazione erano state molto alte e non tutte furono appagate. In quei giorni molti furono i capannelli che si formarono sul “canton di ball”. (…) Il giornale lecchese “La Cronaca” così commentava: “Lo stile, teatrale anzichenò della facciata, sarebbe invero meglio appropriato ad un ippodromo che ad un nosocomio”». Poi, nel 2000 l’inaugurazione della nuova struttura all’Eremo sull’area «acquistata nel 1949 dal Comune di Lecco – scrive Scotti – grazie alla lungimiranza del sindaco di allora, Ugo Bartesaghi. In quell’anno fu infatti messa in vendita l’antica villa Serponti, detta “L’Eremo”, di fondazione secentesca. Nella parte agricola della villa è stata costruita la nuova, grandiosa struttura».
Poi, nel 2000 l’inaugurazione della nuova struttura all’Eremo sull’area «acquistata nel 1949 dal Comune di Lecco – scrive Scotti – grazie alla lungimiranza del sindaco di allora, Ugo Bartesaghi. In quell’anno fu infatti messa in vendita l’antica villa Serponti, detta “L’Eremo”, di fondazione secentesca. Nella parte agricola della villa è stata costruita la nuova, grandiosa struttura». Per Merate, inoltre, ancora la rivista “Archivi di Lecco” ha pubblicato in un numero monografico (il 3 del 2006) la tesi di laurea di Elena Gerosa che racconta una lunga storia di impegno sociale che risale fino al Cinquecento e che sarebbe culminata nel 1837 quando il farmacista Giovanni Battista Cerri lasciò al Comune di Merate molte delle sue sostanze appunto per la costruzione di un ospedale. Anche in questo caso non tutto filò liscio, ma finalmente il 21 marzo 1845 – ci racconta Gerosa - «la Deputazione di Merate annunciava per il successivo 1 aprile l’apertura e l’attivazione dell’“Ospedale per gli infermi miserabili del comune”» nella casa lasciata in eredità da Cerri in via Sant’Ambrogio. L’organigramma: amministratore, il marchese Marco Cornaggia-Medici; direttore e medico curante, Severino Bonfanti; infermieri, Giovanni Consonni e Angela Comi. Non sappiamo se i due infermieri già fossero coniugi nel 1845. Lo erano trent’anni dopo, quando sarebbero stati licenziati per raggiunti limiti di età: lui aveva 73 anni e lei 63 anni. «Come espressamente dichiarato dal regolamento i due dipendenti non avrebbero avuto diritto ad alcuna liquidazione, né tanto meno a una pensione, ma la Congregazione di Carità deliberò comunque di corrispondere, “valutando i lunghi ed utili servizi prestati con zelo e premura lodevoli per un periodo di circa 30 anni”, un assegno vitalizio di 1,25 lire al giorno oltre all’usufrutto di due stanze».
Per Merate, inoltre, ancora la rivista “Archivi di Lecco” ha pubblicato in un numero monografico (il 3 del 2006) la tesi di laurea di Elena Gerosa che racconta una lunga storia di impegno sociale che risale fino al Cinquecento e che sarebbe culminata nel 1837 quando il farmacista Giovanni Battista Cerri lasciò al Comune di Merate molte delle sue sostanze appunto per la costruzione di un ospedale. Anche in questo caso non tutto filò liscio, ma finalmente il 21 marzo 1845 – ci racconta Gerosa - «la Deputazione di Merate annunciava per il successivo 1 aprile l’apertura e l’attivazione dell’“Ospedale per gli infermi miserabili del comune”» nella casa lasciata in eredità da Cerri in via Sant’Ambrogio. L’organigramma: amministratore, il marchese Marco Cornaggia-Medici; direttore e medico curante, Severino Bonfanti; infermieri, Giovanni Consonni e Angela Comi. Non sappiamo se i due infermieri già fossero coniugi nel 1845. Lo erano trent’anni dopo, quando sarebbero stati licenziati per raggiunti limiti di età: lui aveva 73 anni e lei 63 anni. «Come espressamente dichiarato dal regolamento i due dipendenti non avrebbero avuto diritto ad alcuna liquidazione, né tanto meno a una pensione, ma la Congregazione di Carità deliberò comunque di corrispondere, “valutando i lunghi ed utili servizi prestati con zelo e premura lodevoli per un periodo di circa 30 anni”, un assegno vitalizio di 1,25 lire al giorno oltre all’usufrutto di due stanze».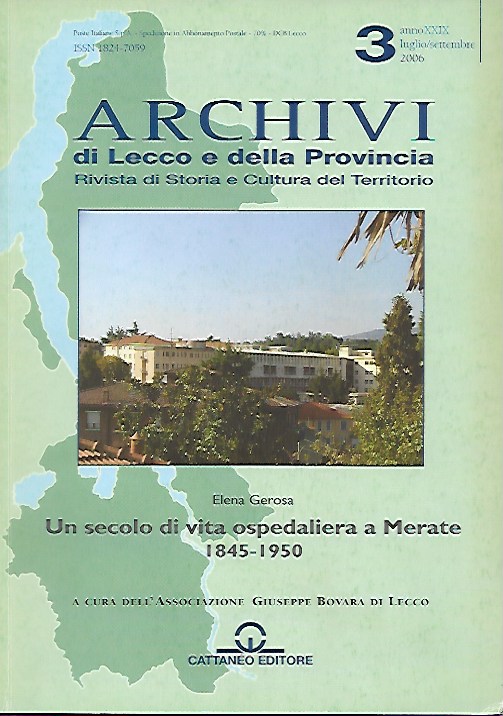 L’ospedale aprì pare senza alcuna cerimonia inaugurale. E il 1° aprile 1845 «furono ricoverate le prime due pazienti: Maria Mapelli di 22 anni e Maria Dozio di 42. Le caratteristiche più evidenti del Nosocomio erano, indubbiamente, le sue limitate dimensioni e la sua conseguente ridotta attività (…) solo sette degenti dall’1 aprile al 31 dicembre 1845. (…) In alcuni anni, addirittura, esso rimase chiuso per diverse settimane, durante la più benevola stagione estiva, per essere poi riaperto al sopraggiungere del freddo». Trent’anni dopo l’apertura, si cominciò a pensare a una nuova sede. La si cominciò a costruire nel 1877 sul luogo dove sarebbe poi rimasto fino a oggi. Gerosa ci accompagna con il suo racconto fino agli Cinquanta e Sessanta del Novecento.
L’ospedale aprì pare senza alcuna cerimonia inaugurale. E il 1° aprile 1845 «furono ricoverate le prime due pazienti: Maria Mapelli di 22 anni e Maria Dozio di 42. Le caratteristiche più evidenti del Nosocomio erano, indubbiamente, le sue limitate dimensioni e la sua conseguente ridotta attività (…) solo sette degenti dall’1 aprile al 31 dicembre 1845. (…) In alcuni anni, addirittura, esso rimase chiuso per diverse settimane, durante la più benevola stagione estiva, per essere poi riaperto al sopraggiungere del freddo». Trent’anni dopo l’apertura, si cominciò a pensare a una nuova sede. La si cominciò a costruire nel 1877 sul luogo dove sarebbe poi rimasto fino a oggi. Gerosa ci accompagna con il suo racconto fino agli Cinquanta e Sessanta del Novecento. Per quanto riguarda Bellano è Scotti a informarci: «La fondazione dell’ospedale Umberto I di Bellano risale al 1908. La decisione di erigere un ospedale nella zona dell’alto lago traeva origine dalla decisione degli istituti ospitalieri di Milano che nel gennaio 1903 avvertiva gli interessati che “attesa l’impossibilità di ricevere nuovi ammalati a motivo dell’eccezionale affollamento nelle infermerie, si doveva sospendere fino a nuova determinazione l’accettazione degli ammalati acuti dei Comuni ammessi per consuetudine al beneficio”». E appunto nel 1908 il nuovo ospedale bellanese apriva i battenti.
Per quanto riguarda Bellano è Scotti a informarci: «La fondazione dell’ospedale Umberto I di Bellano risale al 1908. La decisione di erigere un ospedale nella zona dell’alto lago traeva origine dalla decisione degli istituti ospitalieri di Milano che nel gennaio 1903 avvertiva gli interessati che “attesa l’impossibilità di ricevere nuovi ammalati a motivo dell’eccezionale affollamento nelle infermerie, si doveva sospendere fino a nuova determinazione l’accettazione degli ammalati acuti dei Comuni ammessi per consuetudine al beneficio”». E appunto nel 1908 il nuovo ospedale bellanese apriva i battenti.
La storia di Oggiono e Bosisio è ancora tutta da scrivere: i due ospedali, tra l’altro, sono stati ormai soppressi da tempo. Le riforme sanitarie di fine secolo XX hanno ritenuto di accorpare tutte le strutture pubbliche sotto un’unica amministrazione per evitare la dispersione di risorse a fronte di uno sviluppo della medicina che richiedeva apparecchiature sempre più costose. La riorganizzazione ha mantenuto in vita, oltre a Lecco, l’ospedale di Merate per quanto negli ultimi tempi molti sono i timori sul suo futuro, mentre quello di Bellano è stato trasformato in centro di riabilitazione. Appunto soppressi, invece, Oggiono e Bosisio.
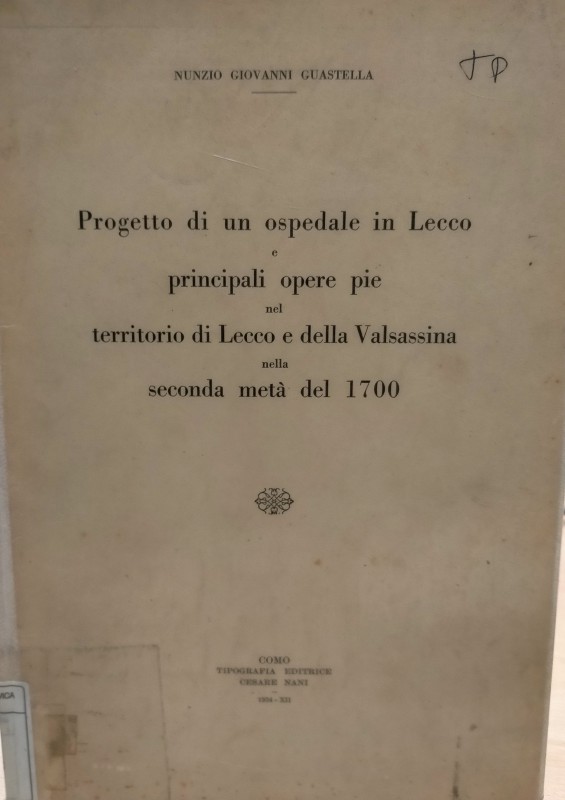
Assodato che i benestanti si curavano, guarivano o morivano, nel proprio letto, a lungo l’assistenza ai poveri era stata più un sostegno contro l’indigenza che un’assistenza sanitaria vera e propria. Ma il legame tra malattia e indigenza era comunque stretto. Quando la malattia costringeva all’inabilità e impediva quindi di svolgere un mestiere si spalancavano spesso le porte della miseria assoluta.
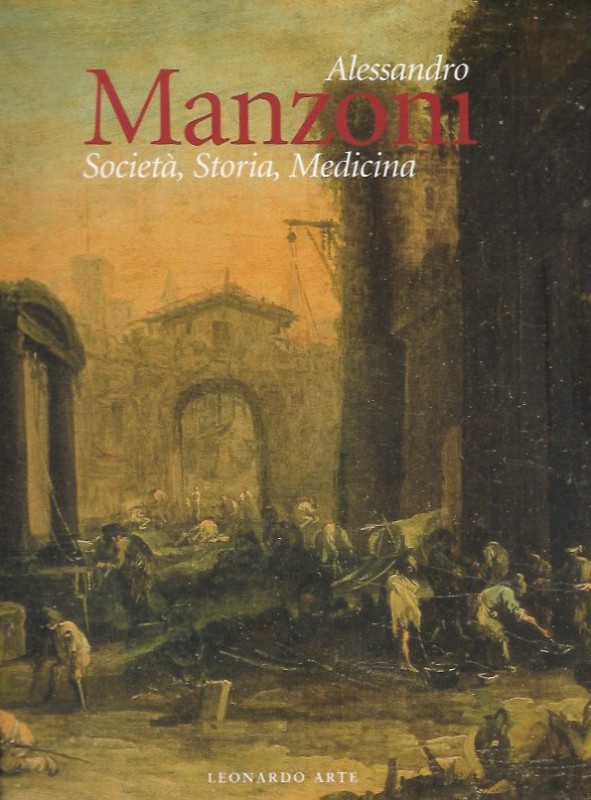
Leggiamo queste parole in un volume, curato dall’allora direttore museale Gianluigi Daccò e dallo stesso Rossetto, uscito nel 2000 proprio in occasione dell’inaugurazione dell’ospedale dell’Eremo: “Alessandro Manzoni. Società, storia, medicina”. Fu pubblicato con l’editrice “Leonardo Arte” dalla stessa azienda ospedaliera quale dimostrazione che la scelta di intitolare la struttura a Manzoni non fosse campata per aria, il solito banale tributo cittadino, l’ennesimo, all’autore dei “Promessi sposi”.
Anni dopo, nel 2007, lo stesso ospedale avrebbe pubblicato un agile libretto su “L’assistenza ospedaliera nel territorio di Lecco. Storia civica di un impegno civile e umanitario” con testi di Gianfranco Scotti a sintetizzare la storia dei tre presidi pubblici ospedalieri sopravvissuti del Lecchese (Lecco, Merate e Bellano) e un intervento del progettista dell’ospedale “Manzoni”, Aurelio Gorgerino.
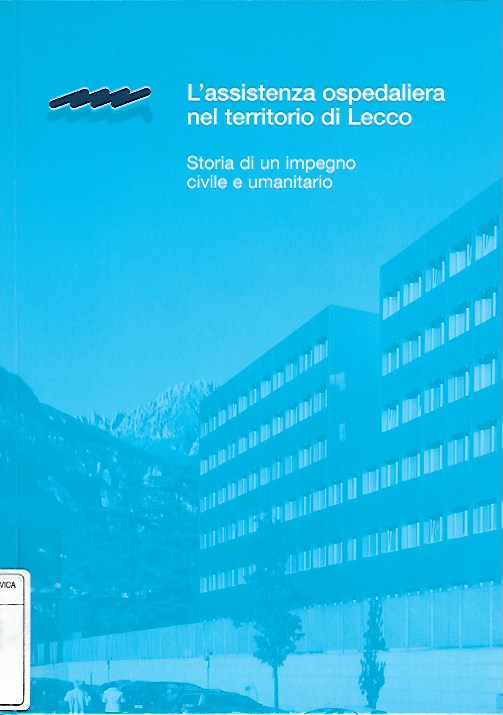
Del resto, in origine era “hospitale”, parola che indicava un tetto per i poveri, ma anche per i pellegrini o i semplici viaggiatori. Ospitale, per esempio, è una località dei Piani d’Erna, dove probabilmente esisteva un punto di appoggio per chi percorreva le strade che collegavano Lecco con la Bergamasca o la Valsassina attraverso Morterone. E’ appunto nell’Ottocento che la differenza si delinea con maggiore evidenza: i ricoveri assistenziali cominciano a evolvere lungo il percorso che arriverà agli ospizi per i poveri e a quelle che oggi sono le rsa (residenze sanitarie assistenziali), mentre sul fronte sanitario sorgono gli ospedali secondo l’accezione moderna.
L’assistenza e la cura erano sempre state sostenute dalla beneficenza e se ne occupavano opere pie e confraternite. Proprio Guastella ne ha catalogate una ventina tra Lecco e la Valsassina: a Lecco, per esempio esisteva, tra le altre, una Scuola dei vivi e dei morti fondata a cavallo tra Cinque e Seicento e che, tra le varie attività. amministrò anche il lazzaretto allestito per la peste “manzoniana” del 1630.
Il primo autentico mattone per un ospedale lecchese fu quello che è ricordato come il lascito Pagani e si risale addirittura al Settecento. Si tratta del testamento redatto il 19 maggio 1741 dall’allora parroco di Acquate Giovanni Battista Pagani (morto nel 1768) con il quale si disponeva «che gran parte delle sue sostanze fosse utilizzata allo scopo di istituire un ospedale per il ricovero e la cura degli infermi e poveri di Lecco»: ce ne parla diffusamente Paola Tettamanzi in “Due secoli di vita ospedaliera a Lecco (1741-1930)”, numero monografico della rivista storica “Archivi di Lecco” (il 4 del 1987).
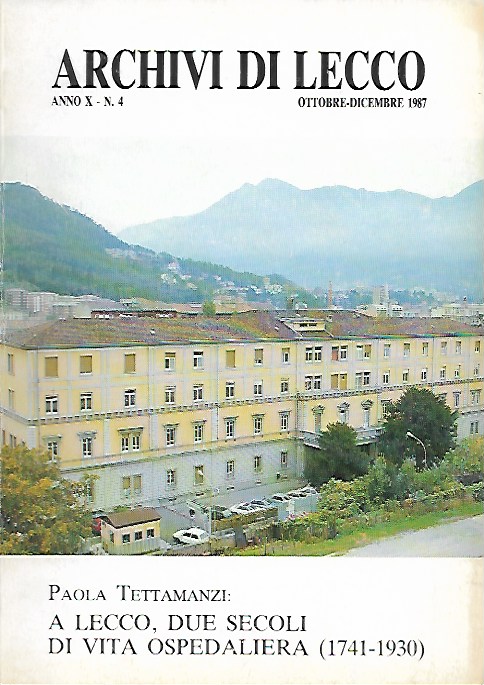
«La necessità di un luogo per la cura – scrive Rossetto – tornò alla ribalta nel 1785, quando il patriziato del territorio lecchese e della Valsassina avanzò una supplica all’imperatore perché fosse eretto un ospedale in città» proponendo di raccogliere i fondi unendo diverse rendite: quelle del Luogo Pio per vecchi impotenti di Lecco, dei soppressi monasteri di San Giacomo a Castello di Lecco e del Cantello in Valsassina e di quell’ospedale di Acquate, realizzato due secoli prima grazie al lascito testamentario del nobile Giovanni Antonio Airoldi, struttura che raccoglieva poveri ma non ammalati e che è la radice prima di quell’Istituto Airoldi-Muzzi di cui si dovrà tornare a parlare. Oltre, naturalmente al già menzionato “lascito Pagani”. «La risposta imperiale non tardò ad arrivare – scrive sempre Rossetto -: con il reale dispaccio del 16 settembre 1785, infatti, venne accordata l’erezione dell’ospedale tanto desiderato assegnando a tale scopo il fabbricato del soppresso monastero di monache di Castello sopra Lecco, situato in aria salubre, ed ove si trovano Medici, Chirurghi e Spezierie». Che fossero i lecchesi, però, a darsi da fare per recuperare i fondi necessari. Fondi che però non vennero trovati a sufficienza e per circa mezzo secolo non se ne fece nulla.
Si dovrà attendere il 1830, quando il ricco possidente lecchese Antonio Muzzi donò ai Luoghi Pii Elemosinari di Lecco la cifra di ventimila lire per la costruzione di un civico ospedale. Amministratore dei Luoghi Pii era don Vittorino Cremona, tra l’altro zio dello scrittore Antonio Ghislanzoni per via materna. E don Vittorino si attivò. Naturalmente non mancarono intralci di varia natura che ritardarono i lavori. Scrive Gianfranco Scotti: «L’articolata vicenda riprende il suo corso con la morte del Muzzi, nel 1837. Due anni prima, egli aveva donato ulteriori ventimila lire milanesi, confidando nella generosità dei suoi concittadini al fine di completare l’erezione dell’ospedale. I lavori spesso interrotti per mancanza di fondi, erano iniziati nel 1836 su progetto di Giuseppe Bovara, figura luminosa nel panorama sociale e culturale dell’Ottocento lecchese. (…) Non solo non pretese di venire ricompensato per il lavoro di progettista, ma addirittura mise a disposizione 3200 lire milanesi del suo patrimonio personale per gli ultimi dieci pilastri del cortile porticato. Il 18 giugno 1843, il nuovo edificio, di nobili quanto sobrie linee neoclassiche, venne inaugurato. Ma il progetto dell’architetto lecchese fu realizzato per un solo quarto, nonostante il generoso lascito del Muzzi».
Quell’edificio esiste ancora ed è la sede principale del Comune di Lecco in piazza Diaz, che impropriamente giornalisti e politici ormai nominano “Palazzo Bovara” solo per il fatto d’esser stato progettato dall’architetto lecchese. L’autentico Palazzo Bovara, infatti, si trova altrove, nell’omonima via Bovara, come da targa restaurata una ventina d’anni fa. Ma tant’è.
«Il 7 agosto 1843 – ci racconta Paola Tettamanzi – si ospitò il primo degente, l’ottuagenaria Rosalinda Bignetti vedova Invernizzi, di Lecco, affetta da forte febbre reumatica. Il ricovero fu dovuto alla pietà nei confronti della vecchia che mancava di ogni mezzo per l’assistenza e sollecitato dal fatto che alcuni lontani parenti si erano offerti di pagare la quota giornaliera. (…) Al termine del 1843, il bilancio statistico confermava l’avvenuto ricovero di quindici malati, tra i quali alcuni paganti e due militari. Cinque furono i decessi, tra i quali tre di tisichezza avanzata. Ordinariamente, in ciascun giorno non si trovavano nel pio luogo che due, tre o al più quattro malati. (…) I ricoverati fino all’anno 1847 si aggirano intorno ad una media di circa 40 malati all’anno. La punta raggiunta nel 1847 è correlata alle misere condizioni alimentari in un anno in cui “per le ingenti richieste di granaglie fatte specialmente dalla Svizzera, veniva quasi quintuplicato il prezzo del pane, della pasta e della farina di polenta”».
Il racconto di Tettamanzi ci avvicina anche all’evoluzione della medicina, alle credenze popolari, alle innovazioni più o meno serie come la catena elettrogena del dottor Wood che assicurava la guarigione senza medicine di tutte le malattie umane.
Proprio accanto all’ospedale, tra l’altro, nel 1863 venne realizzata la stazione ferroviaria. Avrebbe scritto il giornalista Uberto Pozzoli, in un articolo del 1925: «Con treni di notte e di giorno, coi fischi, col tin tan dei respingenti e con le bestemmie dei facchini, gli ammalati non avevano tanto da scegliere: o tornare a casa o andare al manicomio. Fu così che, nella quaresima del 1893, si decise di costruire un nuovo ospedale nelle vicine del Colombaio» come si chiamava una zona di Pescarenico.
Si cominciò dunque prima della fine del XIX secolo a prefigurare il nuovo ospedale lecchese che è poi quello durato un secolo, con ampliamenti e nuovi padiglioni, sulla strada poi intitolata a Ghislanzoni. Si costruì tra 1899 e 1900. «Le aspettative della popolazione erano state molto alte e non tutte furono appagate. In quei giorni molti furono i capannelli che si formarono sul “canton di ball”. (…) Il giornale lecchese “La Cronaca” così commentava: “Lo stile, teatrale anzichenò della facciata, sarebbe invero meglio appropriato ad un ippodromo che ad un nosocomio”».

Ma anche altre strutture erano intanto sorte nel territorio: nel 1845 era stato aperto l’ospedale di Merate, nel 1908 quello di Bellano, nel 1924 a Bosisio Parini e anche Oggiono aveva un proprio nosocomio.
Nel volumetto di Scotti e Gorgerino troviamo alcune notizie su Bellano e Merate. 
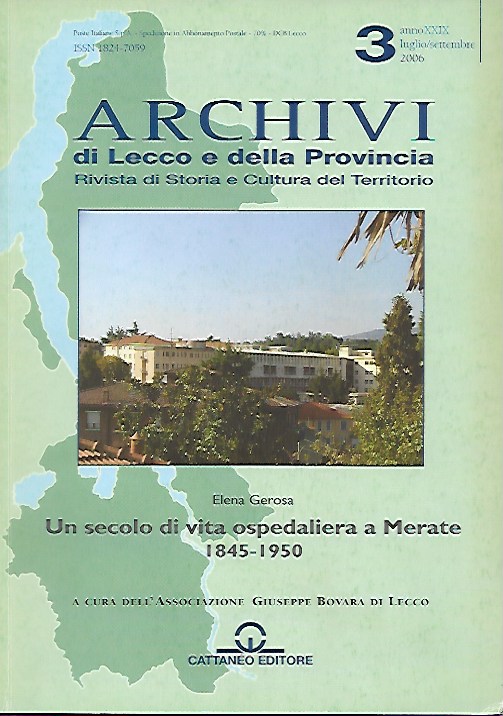

La storia di Oggiono e Bosisio è ancora tutta da scrivere: i due ospedali, tra l’altro, sono stati ormai soppressi da tempo. Le riforme sanitarie di fine secolo XX hanno ritenuto di accorpare tutte le strutture pubbliche sotto un’unica amministrazione per evitare la dispersione di risorse a fronte di uno sviluppo della medicina che richiedeva apparecchiature sempre più costose. La riorganizzazione ha mantenuto in vita, oltre a Lecco, l’ospedale di Merate per quanto negli ultimi tempi molti sono i timori sul suo futuro, mentre quello di Bellano è stato trasformato in centro di riabilitazione. Appunto soppressi, invece, Oggiono e Bosisio.
Dario Cercek