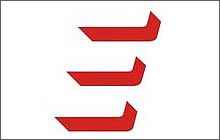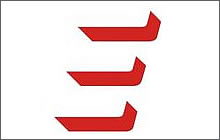SCAFFALE LECCHESE/117: Felice Bassani e i 'medegozz di nost vecc'
Deve esserci anche qualcosa di ancestrale in certa diffidenza nei confronti della medicina ufficiale. Quella diffidenza che, seppure sempre presente un po’ sotto traccia, viene alla luce nei tempi più inquieti come questi anni pandemici. Quando si è magari tentati dal far da sé come si usava una volta. Considerato che – stando a un proverbio - «i sbagli di dutûr i van sott tera senza tant rumûr». La storia medica è complessa e affascinante, oltre che crudele. Se la medicina popolare ha dovuto fare i conti con l’accusa di stregoneria, non che quella oggi ufficiale non abbia sollevato sospetti da parte dell’autorità religiosa per la quale l’unica cura, in fondo, era la sola preghiera. Venendo l’anima prima del corpo. Il viluppo degli atteggiamenti si spiega dunque con vicende secolari aggrovigliate. Che non sta a noi districare. Ma di ciò va tenuto conto affrontando la lettura di una ricerca pubblicata nel 1981 da quella tipografia Bertoni che a Merate fu a lungo un’istituzione: “I medegozz di nost vecc” vale a dire «come si curavano un tempo i nostri vecchi, nel territorio lecchese e comasco, quando non c’erano le medicine». Autore, Felice Bassani, insegnante che tanta attenzione ha dedicato alla cultura popolare e che i lettori di questa rubrica hanno già incontrato a proposito di “dialetto da salvare”. Nella sua ricerca, Bassani ha intervistato gli anziani dell’epoca, tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, quando il legame con la civiltà contadina e con le tradizioni secolari non si era reciso del tutto ed era quindi ancora possibile rintracciare le testimonianze di un patrimonio antico tramandato oralmente, raccogliere il capo di un lungo filo risalendo il quale si sarebbe andati indietro di molti secoli.

Felice Bassani
Del resto «le persone intervistate – scrive Bassani – citano infatti non di rado “episodi” in cui i medici fanno brutte figure (…) “E’ sempre la stessa storia – si difendeva a volte l’interessato -: se il malato guarisce il merito è di Sant’Antonio, se muore è colpa del medico!».
Il fatto è «che era proprio così: la gente in genere chiamava il medico solo in casi estremi, quando la situazione dell’ammalato era ormai molto grave e tanto valeva tentare “anche” col medico». E del resto «i servizi sanitari erano scarsi, le medicine rare, la diffidenza verso i pochissimi medici notevole e, tutto sommato, per curarsi e mantenersi in salute, i nostri vecchi ricorrevano molto più facilmente all’insegnamento del gruppo, agli elementi forniti dalla natura, alle pratiche tradizionali di tipo religioso o superstizioso e quindi attingevano, assai più che al patrimonio della scienza, a quello della loro cultura. (…) Tanto per fare un esempio, oggi giudicheremmo “mostruosa” una disinfezione fatta con la terra, con le ragnatele. con l’orina: eppure una volta veniva praticata regolarmente perché consacrata dalla tradizione; e assai probabilmente certi insuccessi erano largamente compensati dai successi ottenuti attraverso la suggestione. (…) E’ molto importante rilevare anche come questa fede nei “medegozz” sia spesso sostenuta da un altro tipo di fede, quella religiosa, a cui sono da aggiungere certe credenze in forze misteriose o magiche di tipo soprannaturale: quella che noi chiamiamo “superstizione”. (…) Per questo la parola “medegozz” ci sembra intraducibile in italiano: in ogni caso essa comporta un atto di fede in “qualcosa” che guarisce; ma questo qualcosa non sempre è un medicamento del tipo che in genere intendiamo noi».
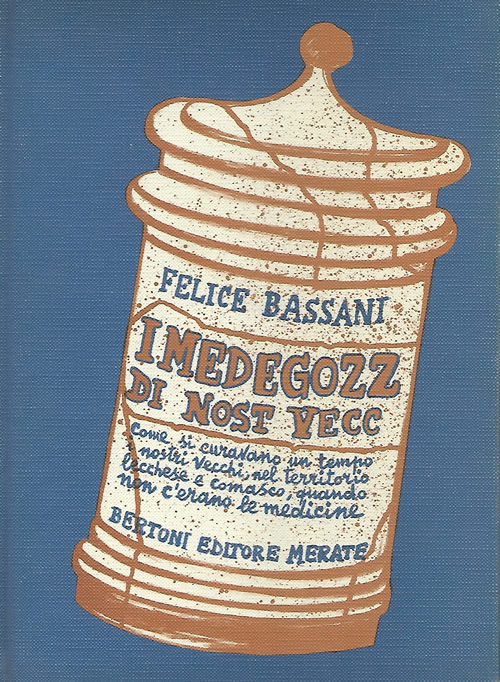
Naturalmente, non tutta la medicina popolare è di questo tenore. La proprietà delle erbe è patrimonio ormai consolidato e la stessa industria farmaceutica moderna vi fa ricorso, magari riducendone lo spettro d’uso un tempo estesissimo andando a curare malanni che di ben altro avrebbero avuto bisogno.
Si usava l’aglio per l’ipertensione arteriosa ma anche per i vermi. l’arnica e la malva servivano per le infiammazioni, l’aceto per le scottature e gli svenimenti, i limoni contro la diarrea, la menta contro i raffreddori. Al latte con la cipolla si ricorreva contro il mal di gola, Ma si versavano l’olio e il burro sulle ustioni, si utilizzavano le calze sporche, la calce, la cenere calda, mentre la cotenna di lardo veniva buona contro la calvizie e la lana sporca contro gli orecchioni, le lumache vive contro l’ulcera, il pancotto (aglio, malva, pancetta e olio) per smaltire la sbronza, i pidocchi inghiottiti vivi contro l’itterizia, lo sterco di gallina per lenire il mal di pancia e quello di mucca per le punture di insetti ma anche contro le bronchiti e i reumatismi, le tegole calde per la sciatica, lo zolfo contro la rogna e la zucca contro il tifo, i sassi bollenti dopo un’indigestione, la rugiada per i problemi alla vista, Contro l’enuresi (la pipì a letto) si faceva bere ai bambini acqua nella quale era stato fatto bollire un topo; però in Val d’Intelvi i topi venivano fritti nell’olio per poi essere mangiati e chissà che, a fronte di certe diete povere, ciò che oggi disgusta allora non fosse invece una ghiottoneria. E a proposito di bambini, c’era anche il problema che tutto si portavano alla bocca e che magari finivano con l’inghiottire qualcosa che non dovevano: «in genere in questi casi si provocava il vomito. A Lecco si faceva bere un albume d’uovo e poi un bicchiere d’acqua salata molto calda. L’albume si raggrumava attorno al corpo estraneo e l’acqua salata lo faceva rimettere». Tra l’altro, l’albume si usava anche contro le scottature e il mal di denti ma anche per curare le fratture in genere e le distorsioni. Ci fermiamo qui.

Nel corso del Novecento e molto gradualmente «la nostra gente si è accorta dell’inefficacia di certi “medegozz” e si è via via convertita alla medicina scientifica (…) Come tante altre cose, seppure discutibili, del nostro passato, una volta perdute ci hanno lasciato un senso di rimpianto, così questi antichi medicamenti, scomparendo, hanno lasciato in noi un poco di amarezza. In questa riflessione, il dato scientifico, scontato, non ci interessa più - Il “medegozz” (…) significava molto per la nostra gente: era il simbolo di quella sapienza che si tramandava di padre in figlio e che stabiliva una preziosa continuità tra le generazioni: era il simbolo della fede che dà forza nelle avversità, quando l’uomo non ha più nessun appiglio e potrebbe sentirsi perduto: fede non solo nei propri “vecchi”, ma anche nella forza rigeneratrice della natura e della divinità. Per questo, con la sua scomparsa, anche questo aspetto della cultura dei nostri vecchi, così come il dialetto, i proverbi, il mangiare, le feste, le leggende, le tradizioni e tante altre cose, contribuisce a lasciare un vuoto. (…) Oggi c’è la moda del dialetto, dei cibi “genuini”, delle feste paesane e così via (anche la moda dei “medegozz” si intravede ad esempio in un certo ritorno alle erbe curative). Ma le mode non ripetono mai le “esperienze” passate e chi segue le mode non fa cultura (si illude solo di farne). L’atteggiamento più serio di fronte alle cose passate è sempre quello dello studioso e dell’appassionato che non vuole fare rivivere ciò che è morto, ma vuole semplicemente “capire” ciò che appartiene alla storia della sua gente».
PER RILEGGERE LE PUNTATE PRECEDENTI DELLA RUBRICA CLICCA QUI
Dario Cercek