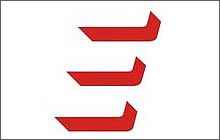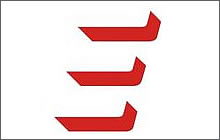SCAFFALE LECCHESE/109: tutte le 'traduzioni' dei Promessi Sposi... in dialetto
«Chell brasc del lâch de Còm». Suona così, in dialetto lecchese, il celebre incipit manzoniano del ramo del lago di Como. Però a Premana si declina con «què le gambe dòl laach». Quel ramo, dunque, diventa braccio e diventa gamba. Magie linguistiche. Testimonianza di come le lingue si trasformino da luogo a luogo, soprattutto i dialetti, per secoli parlata corrente senza che avesse una codificazione e pertanto libera di trasformarsi, adattarsi, evolversi, seguire linee inusitate. Prima di avviarsi all'estinzione che è storia del nostro tempo, soppiantato da quell'italiano unificante che proprio il romanzo manzoniano impose sulla babele italica. Romanzo che poi, per diletto, si è cominciato a condurre in forme vernacolari le più varie: sono addirittura catalogate una versione ladina e una barese.
Che poi, tradurre in dialetto i "Promessi sposi" sarebbe proprio «una bella presunzione»: così infatti obiettava un ipotetico censore all'avvocato che decise di imbarcarsi nell'impresa di volgere in milanese i dialoghi del romanzo manzoniano. Peraltro ormai da tempo tradotto «in tutte le lingue del mondo», la replica del legale, in tal modo sottintendendo che non ci sarebbe stato tradimento alcuno nei confronti dell'opera fondatrice della lingua italiana moderna. Perché ciò, a conti fatti, è quanto si contesta a coloro che s'avventurano in analoghi progetti: una sorta di lesa maestà, uno sgarbo alla memoria di Alessandro Manzoni che scrisse il suo romanzo e andò poi a "risciacquarlo in Arno", per depurarlo dei troppi lombardismi, e farne manifesto nella battaglia per una lingua che unisse gli italiani. Non potendo che essere, quella lingua, il toscano di Firenze. All'epoca del Manzoni (1785-1873), si sa, la lingua italiana non esisteva, Quella frequentata in letteratura, non era parlata da nessuno nella quotidianità. Lo stesso Manzoni la bollava come lingua morta. La lingua madre, la lingua viva, era per tutti il dialetto locale e, sotto questo aspetto, la carta italiana si presentava oltremodo variegata. Una situazione che si protrasse, come sappiamo, ben oltre l'avvenuta unità politica del 1861 e fino alla seconda metà del Novecento. Oggi, che qualcuno possa prendersi la briga di tradurre in dialetto i "Promessi sposi" può apparire curioso, un'operazione gratuita, un esercizio di stile, un virtuosismo fine a sé stesso.
Che poi, tradurre in dialetto i "Promessi sposi" sarebbe proprio «una bella presunzione»: così infatti obiettava un ipotetico censore all'avvocato che decise di imbarcarsi nell'impresa di volgere in milanese i dialoghi del romanzo manzoniano. Peraltro ormai da tempo tradotto «in tutte le lingue del mondo», la replica del legale, in tal modo sottintendendo che non ci sarebbe stato tradimento alcuno nei confronti dell'opera fondatrice della lingua italiana moderna. Perché ciò, a conti fatti, è quanto si contesta a coloro che s'avventurano in analoghi progetti: una sorta di lesa maestà, uno sgarbo alla memoria di Alessandro Manzoni che scrisse il suo romanzo e andò poi a "risciacquarlo in Arno", per depurarlo dei troppi lombardismi, e farne manifesto nella battaglia per una lingua che unisse gli italiani. Non potendo che essere, quella lingua, il toscano di Firenze. All'epoca del Manzoni (1785-1873), si sa, la lingua italiana non esisteva, Quella frequentata in letteratura, non era parlata da nessuno nella quotidianità. Lo stesso Manzoni la bollava come lingua morta. La lingua madre, la lingua viva, era per tutti il dialetto locale e, sotto questo aspetto, la carta italiana si presentava oltremodo variegata. Una situazione che si protrasse, come sappiamo, ben oltre l'avvenuta unità politica del 1861 e fino alla seconda metà del Novecento. Oggi, che qualcuno possa prendersi la briga di tradurre in dialetto i "Promessi sposi" può apparire curioso, un'operazione gratuita, un esercizio di stile, un virtuosismo fine a sé stesso.

Ne è cosciente Gianfranco Scotti che i lecchesi conoscono proprio per i suoi studi dialettali (è tra gli autori del Vocabolario del dialetto lecchese) e apprezzato per l'interpretazione della poesia di Carlo Porta. Proprio Scotti, nel 2013 ha pubblicato per l'editore Cattaneo "I promessi sposi (Stòria milaneśa del sécul XVII) vultaa in dialètt de Lècch". Che è l'unica autentica traduzione letterale del romanzo. Essendo gli altri esempi, vere e proprie rielaborazioni: versioni in poesia, poemi o poemetti, taluni più fedeli, tal altri più "liberi". Scotti spiega nella presentazione al suo lavoro: «Sono stato mosso soprattutto dal desiderio di mettere alla prova un sistema linguistico "povero" come la nostra parlata locale, per verificare la sua capacità di reggere il confronto con l'italiano e segnatamente con l'altissima qualità della prosa manzoniana e credo di poter dire che questa variante rustica del milanese ha saputo restituire, sia pure non sempre in modo compiuto, le sfumature, i concetti elevati, le preziosità lessicali del testo originale, a comprova che ogni lingua e ogni dialetto sono in grado di rendere il pensiero, di essere strumento di comunicazione e di speculazione intellettuale, di confrontarsi con quegli idiomi, anche i più illustri, depositari di una antica tradizione letteraria». E si è anche trattato di un'occasione «per recuperare la ricchezza del vocabolario storico del dialetto lecchese e per ridar vita a termini ed espressioni da gran tempo usciti dall'uso o di ormai rara applicazione da parte dei parlanti». Inoltre, «è sembrato interessante volgere il romanzo nella lingua dei suoi protagonisti, la lingua di Renzo, di Lucia, di Agnese e di Perpetua. Uno degli appunti che furono rivolti al Manzoni riguardava proprio la lingua nella quale si esprimono i personaggi del popolo, quella "gente meccanica" che non poteva conoscere altro che il dialetto del luogo natio. L'italiano spesso ricercato che Manzoni mette in bocca a Renzo, a Lucia e alle altre figure di umile estrazione che agiscono sulla scena del romanzo, stride infatti con la loro condizione e ne indebolisce l'autenticità».
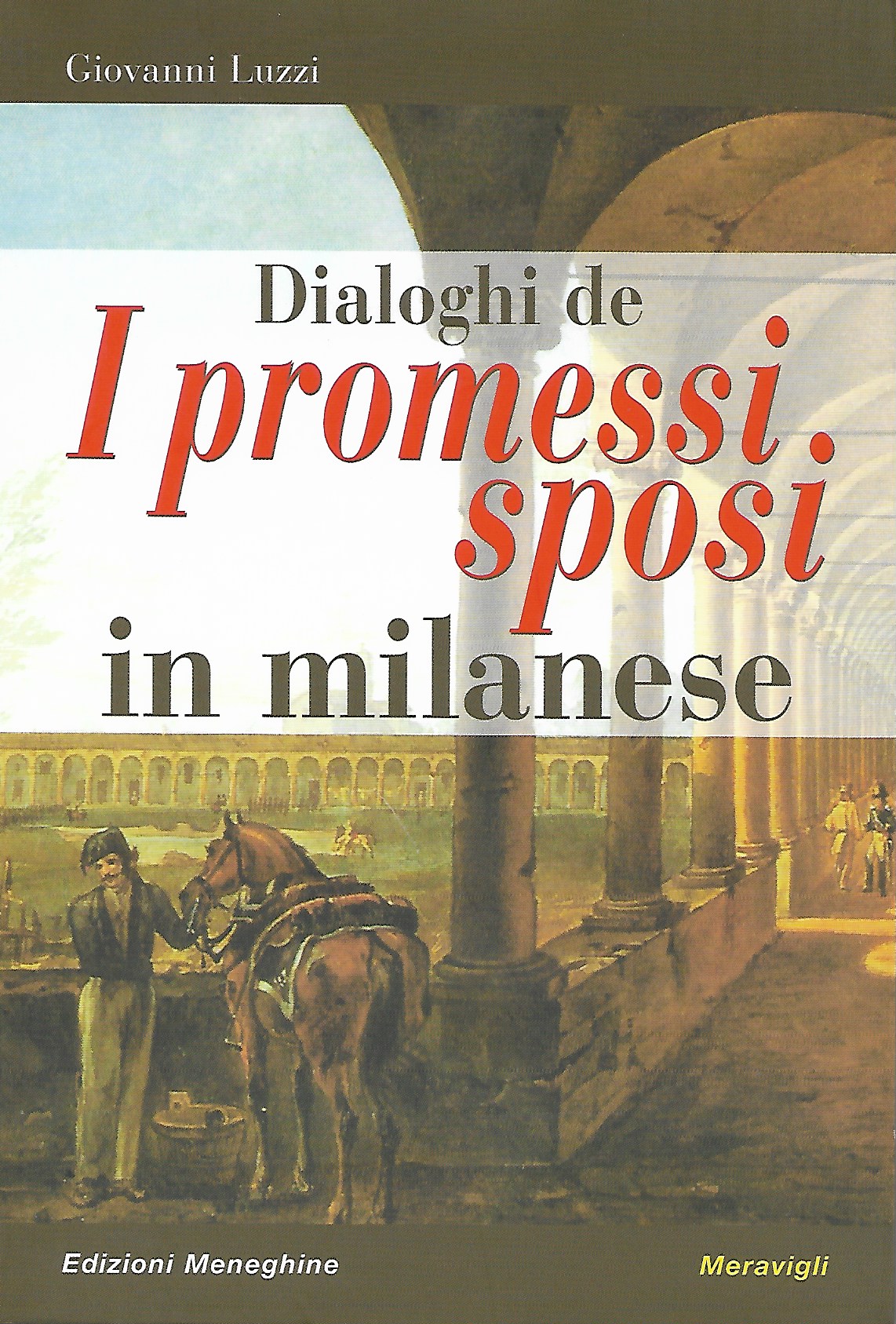
A ciò pensava anche Giovanni Luzzi, che sarebbe poi l'avvocato alle prese col "censore" al quale abbiamo accennato nelle prime righe. Definitosi, "meneghinologo", oltre all'attività forense, si dedicava alla scrittura di "cose milanesi" e fu tra i fondatori dell'Accademia del dialett milanes". Suo è il volumetto "Dialoghi de 'I promessi sposi' in milanese" pubblicato dalla milanese "Meravigli Edizione" nel 2015, quando egli era scomparso ormai già da un po' di anni, essendo morto ottantenne nel 1982. Ai più cavillosi, resterà comunque la convinzione che il dialetto parlato nel Seicento non sarà certo stato quello che nel corso Ottocento ha trovato una sua forma scritta. Né a Milano né tanto meno nelle campagne.
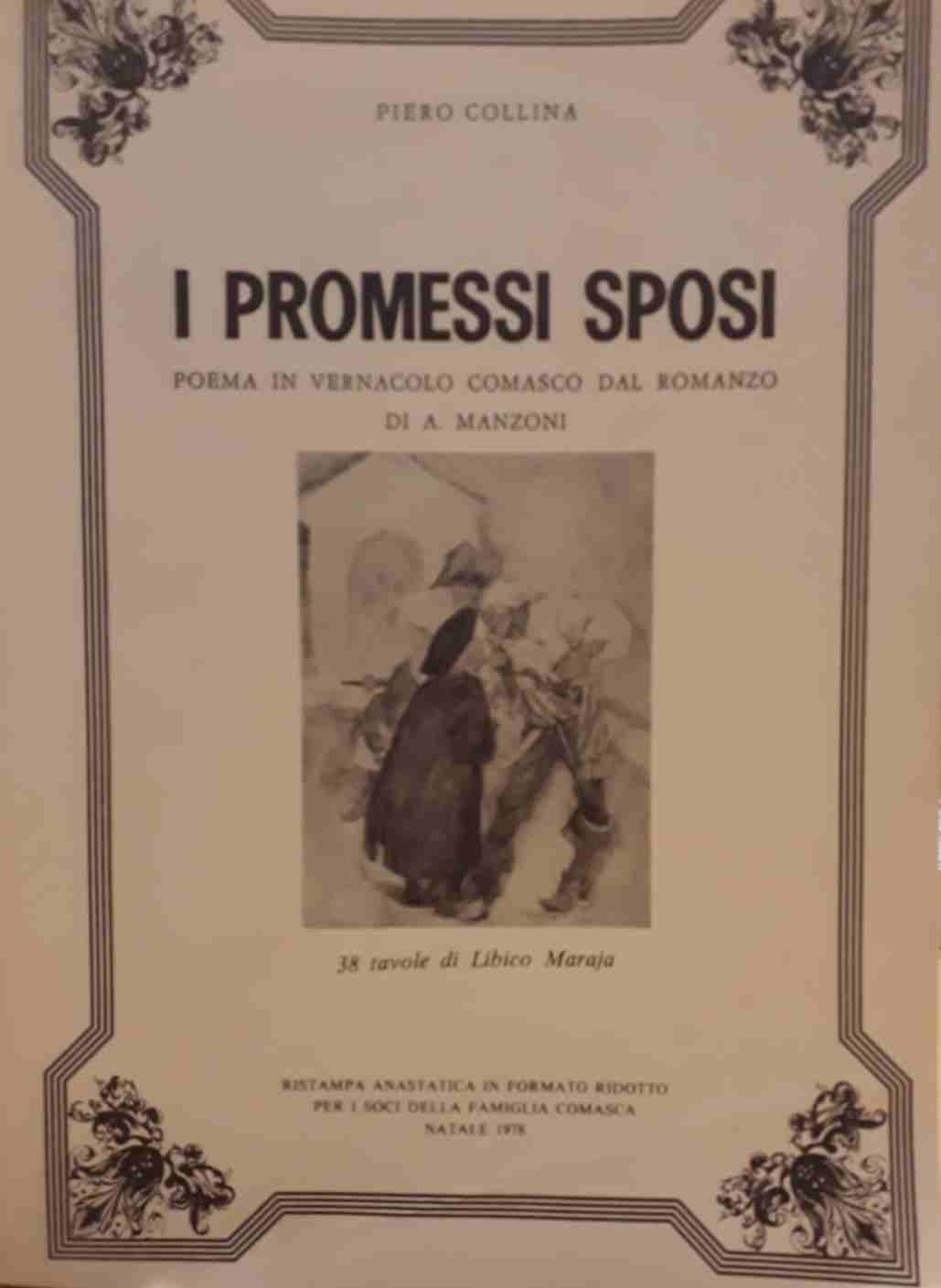
Poco male, in fondo, stando a ciò che dice il comasco Piero Collina autore dei "Promessi sposi" in "vernacolo comasco" (a cura dell'associazione "Famiglia Comasca", 1966, poi ristampato nel 1978): «I miei quattroversi hanno lo scopo di raccontare la storia di Renzo e Lucia, così alla buona, a gente molto alla buona. (...) Il dialetto che ho scritto è la prima lingua che ho imparato, quella parlata (...) da tutta quella gente pittoresca del mio caro Rungiun (un quartiere di Como, ndr), che adesso, quelle poche volte che parla il dialetto, certe parole d'allora non le pronuncia più. Insomma, il dialetto di cinquant'anni fa era un dialetto pṻssee spetasciaa di quello che si parla al giorno d'oggi. Però, io non ho trascurato nemmeno quest'ultimo. Nel mio racconto, infatti, fanno ogni tanto fanno capolino certe parole in lingua (dialettizzate o meno) e certi accenti gravi milanesi, che sono propri del dialetto attuale, e ciò per rendere più vero il racconto (considerato che il racconto è un comasco del giorno d'oggi) e per dare, di conseguenza, maggior risalto al dialetto dei dialoghi (specie tra i personaggi più nostrani)» tra l'altro scegliendo di far parlare qualcuno in milanese (don Rodrigo, i bravi, il cardinale, la monaca di Monza...) e qualcun altro in comasco (L'Innominato, il Nibbio....).
E comunque - osserva ancora Scotti - «lo stesso Manzoni, come sappiamo, era stato tentato di scrivere il romanzo utilizzando il dialetto milanese, la lingua che insieme al francese, padroneggiava perfettamente». E conclude: «Se tradurre significa inevitabilmente anche tradire, ci deve però confortare la considerazione che la celeberrima vicenda narrata dal Manzoni viene qui riproposta con accenti, certamente più dimessi, ma in una lingua vibrante di suoni, in grado di regalarci immagini di grande suggestione, quella lingua che sentiamo ancora nostra, pur nel progressivo e inarrestabile declino, ancora elemento irrinunciabile della nostra identità e della nostra cultura». Un destino, quello dei dialetti, che si è compiuto nel giro di un secolo. Agli inizi del Novecento, per esempio, un testo scolastico per insegnare la grammatica italiana nelle scuole elementari si raccomandava che «nell'apprendimento, all'aumento, alla gloria della lingua nazionale, sia dato per iscorta il dialetto debitamente studiato, coltivato, onorato». Autore, Ciro Trabalza, storico della lingua, critico letterario e docente. L'anno era il 1917. Si era dunque in piena prima guerra mondiale, quando al fronte si ritrovavano giovani soldati provenienti dalle più disparate parti d'Italia e che avevano qualche problema nel comprendersi tra loro. Se certa retorica patriottarda ci racconta di una Grande Guerra come autentica levatrice dell'unità nazionale, il momento in cui finalmente s'affratellava quel popolo così assente nelle lotte risorgimentali, è indubbio che fu l'occasione di una presa di coscienza collettiva. Ancora nel 1917, dunque, la lingua degli italiani era il dialetto e quindi dal dialetto si dovevano prendere le mosse per insegnare l'Italiano. Trabalza cita altri studiosi: «Siam d'opinione che lo studio della grammatica non dovrebbe farsi astraendo dai dialetti locali». Cita Luigi Morandi che fu docente e parlamentare: «Poiché nel luogo ove risiede la scuola si parla un dialetto (...) gioverebbe avessimo dei buoni vocabolari dialettali italiani (...). Alla mancanza di questo supplica per quanto possibile lo zelo degli insegnanti», E cita il pedagogista Giuseppe Lombardo Radice: «Il dialetto è una lingua viva, sincera, piena ed è la lingua dell'alunno» e allora «tradurre le novelline e i canti del popolo sarebbe un degno ed alto esercizio scolastico». Quindi - scrive Trabalza - «regione e nazione celebrano la loro individualità, la loro libertà pur vivendo in piena concordia, anzi in una perfetta fusione» E quale prova «di questa mutua compenetrazione intendiamo offrire le versioni di un brano dei "Promessi sposi" nelle parlate delle varie zone dialettali italiane. Ivi ognuno vedrà sfolgorare nella parola, e più nelle forme, e più nel costrutto, e più ancora nella potenza espressiva, insomma nel suo caratteristico atteggiamento spirituale, la medesima, sebbene variamente riflessa, italianità che rifulge nella limpida prosa manzoniana». Il brano scelto è quello del racconto del miracolo delle noci da parte di fra' Galdino ed è appunto proposto in 18 versioni: dal siciliano di Palermo al friulano di Udine, dal triestino al calabrese di Cosenza, dal pugliese di Lecce al piemontese di Torino, dal romanesco e al napoletano, financo al corso di Bastia e alle parlate lombarde della Val Bregaglia (nella traduzione di Gaudenzio Giovanoli) e naturalmente di Milano (nella traduzione di Carlo Salvioni): «Oo! G'avi dunca de savè che in quel cunvent ghe stava un fraa di noster, che l'era un sant e che ciamàven fraa Macari».

Tornando a noi, due anni prima di Scotti, nel 2011, era stato Antonio Bellati, scomparso 72 anni nel 2013, a cimentarsi in una versione in premanese del romanzo manzoniano: "Ol Lorènz di Tramaìn e la Lüzìe di Mondèi spüüs prumetűü" (edito dall'associazione culturale "Il Corno" anche se stampato da Cattaneo). A lungo un autentico guardiano della tradizione premanese, autore egli stesso di un dizionario di dialetto premanese e fondatore del museo etnografico, alla traduzione integrale del romanzo aveva preferito la forma della poesia che «mi avrebbe più facilmente permesso di rispettare il testo manzoniano pur elaborandolo liberamente; cercando insomma di restare fedele al senso, allo spirito, pur esprimendo il tutto sotto diversa forma, una forma che mi avrebbe permesso qualche originalità», arrivando così a comporre «una lunga favola dialettale, con le cadenze, con le forme di quelle che in passato le persone "specializzate" raccontavano in stalla, e mi pareva di sentire in quei ritmi, in quelle esclamazioni, in quegli intermezzi, l'eco di voci antiche, trapassate, autentiche!».
Senza nascondere un certo timore nell'affrontare il celebre "Addio monti": «Tendevo impaziente alla fine del capitolo ottavo, ma intanto avevo steso brani che mi avvincevano e che, naturalmente a torto, mi sembravano "miei"... E venne il momento dell'Addio monti. Era sera e di solito a sera non lavoro, ma quella sera ero impaziente. Quei cento versi furono stesi in meno di due ore... e mi fecero piangere». Leggiamo: «Adìo montàgn che vegnìi sṻ dal lach/ e tochèe 'l iel cón scim sempre svarièe...».
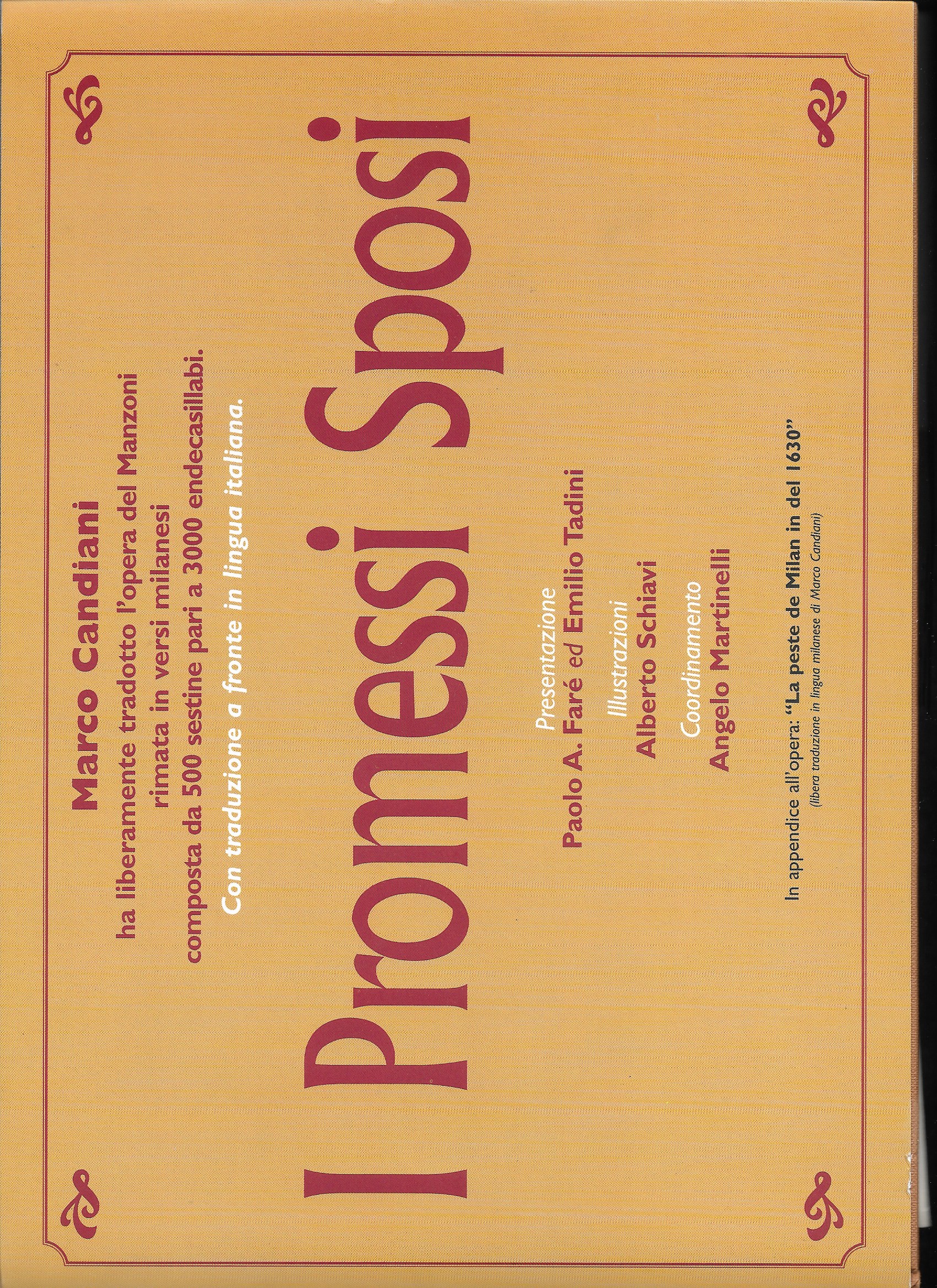
Così come Trabalza proponeva le traduzioni in dialetto del brano manzoniano quale veicolo per imparare l'Italiano, oggi la traduzione dei "Promessi sposi" appare quindi una maniera per tenere in vita il dialetto: «Mi auguro - scriveva il milanese Marco Candiani introducendo la sua versione del romanzo manzoniano (stampata nel 1999 dalle Arti Grafiche Marketpress) - sia scomparsa per sempre l'errata e spocchiosa concezione per cui si considerava il dialetto una storpiatura della lingua ufficiale e una forma inferiore di espressione. Rendiamoci conto, una volta per sempre, che la distinzione tra lingua e dialetto è un problema di indole essenzialmente pratica e non ha nulla di scientifico. Il dialetto è semplicemente un linguaggio che, per ragioni storiche, non ha fatto "carriera"». Tra l'altro, sembra essere diletto diffuso. Spulciando nei cataloghi delle biblioteche, ora che internet ci apre incredibili praterie, ci si imbatte in più d'un titolo. «Non sono pochi coloro che hanno tentato di volgere in lingua milanese il capolavoro del Manzoni; io stesso ho avuto modo di leggere alcune di tali versioni, sia in prosa, quanto in versi; credo che più di un manoscritto di tali tentativi, sia conservato negli scaffali della nostra Biblioteca Ambrosiana»: così scriveva, per esempio, Severino Pagani nell'introduzione a un poemetto pubblicato nel 1974 e ripubblicato nel 1983 dalla lecchese Edizioni Agielle, "I duu moros".
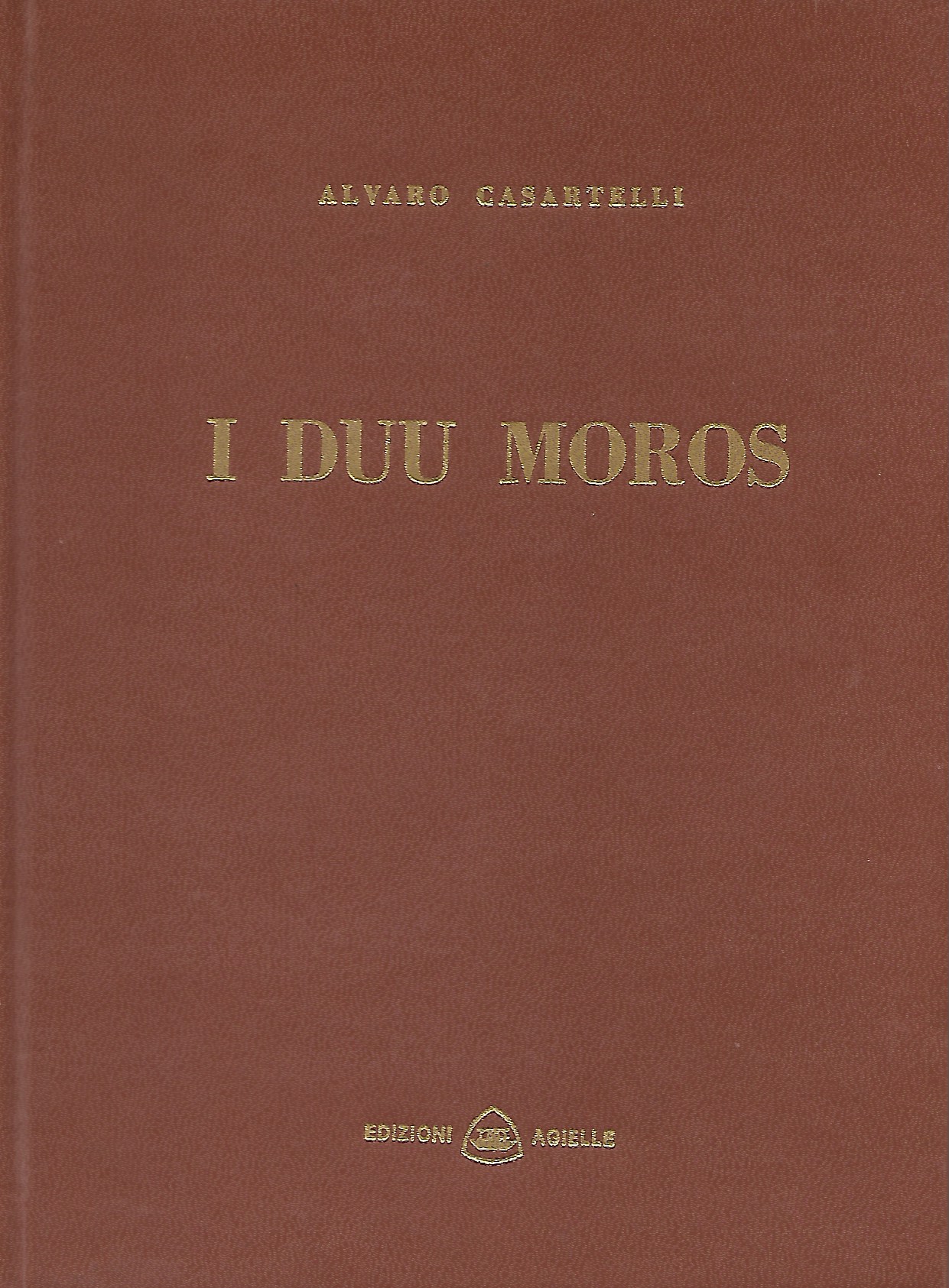
Autore Alvaro Casartelli, perito tessile di Lentate sul Seveso con la passione della poesia in milanese e che qualche considerazione deve avere avuto se il suo paese gli ha anche intitolato una via. Lo stesso titolo del libriccino stampato nel 1966 e opera di un altro milanese, Nino G. Casiraghi, che conteneva una versione «in poesia meneghina» dei primi quattro capitoli del romanzo «con la speranza e l'illusione di completare l'opera». Dell'autore nulla sappiamo, come nulla sappiamo dell'Accademia internazionale della tavola rotonda che promosse la pubblicazione con lo scopo di raccogliere contributi per la «costituzione di un primo fondo per il finanziamento di una campagna antilebbra».
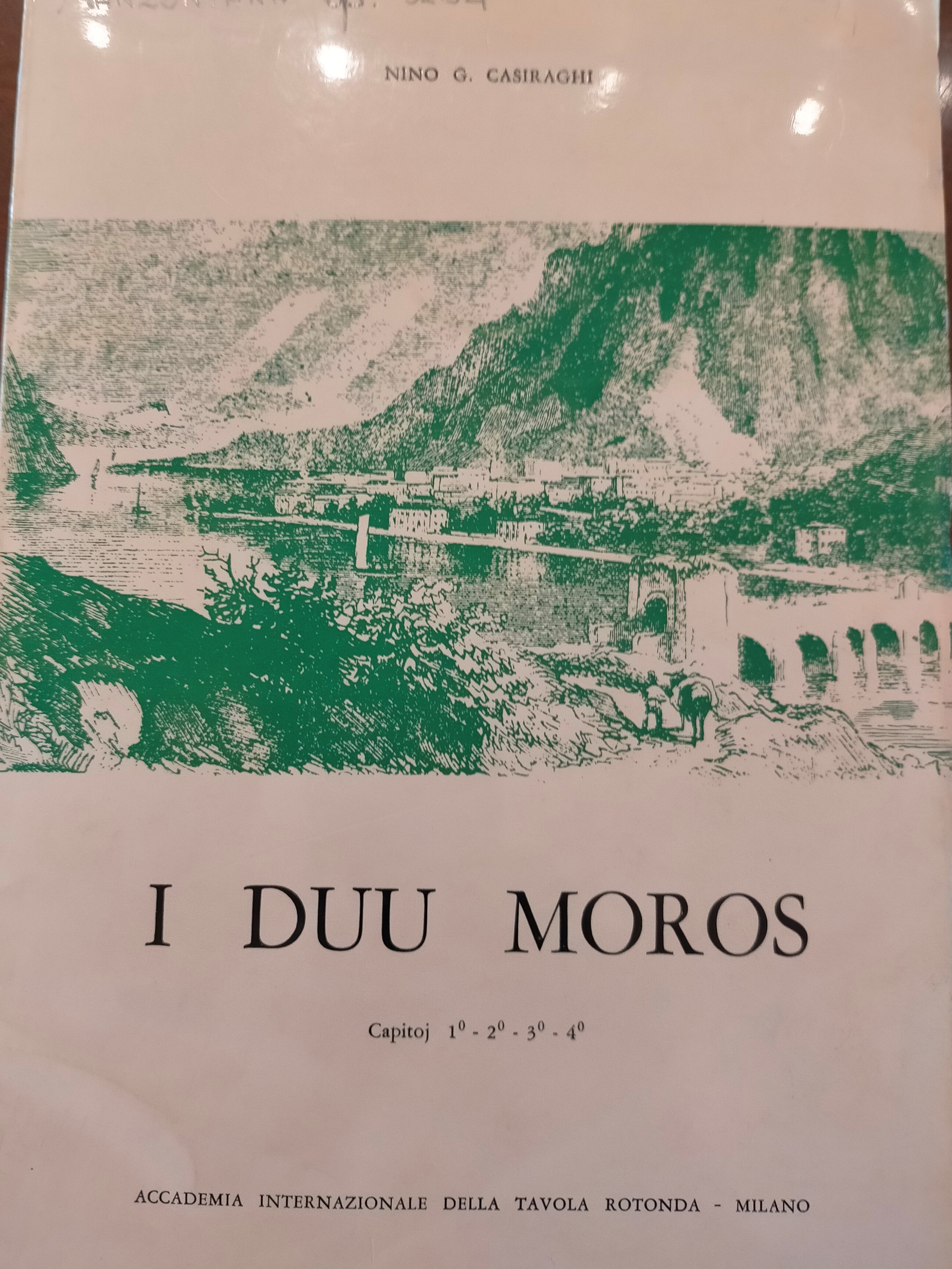
A farci sobbalzare è il passo dell'incontro di don Abbondio con i due bravi. Che restano sempre bravi un po' in tutte le versioni, magari colorando un po', come in Collina: «Bravi, eran bravi, ma eran minga bun!». In Casiraghi li troviamo anche definiti "balabiott" che è gustoso e lombardissimo epiteto (varrebbe, secondo il "Vocabolario lecchese", bambo, bamboccio, baggiano, baciocco, stupidone), non prima d'aver però letto di «duu sbirr de l'aria disinvolta (...) daven l'aria de véss duu partigian!». Vai a sapere...
Dario Cercek