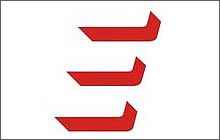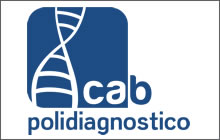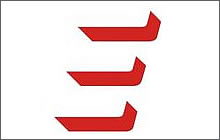SCAFFALE LECCHESE/94: I Promessi Sposi 'riletti' dal romanzo di Alessandro Zaccuri
«Dio perdona tante cose, per un'opera di misericordia»: sono le parole di Lucia all'Innominato nel celeberrimo capitolo XXI dei "Promessi sposi". Meglio: sarebbero. Se tale romanzo fosse stato davvero scritto. E non è così. Non lo era almeno nel luglio del 1841, quando moriva la marchesina Giulia Beccaria, quasi ottuagenaria e ancora nubile. Scritto, forse, quel romanzo lo sarà poi. Chissà. Nemmeno c'è certezza dell'esistenza del suo autore. Almeno come siamo abituati a pensarlo. Del resto, come la memoria alla lunga mischia e confonde cose vissute e cose sognate, «a volte si crede di ricordare quello che non si è mai letto, altre volte non si ricorda quello che si è letto».

E' quanto ci racconta lo scrittore Alessandro Zaccuri, origini spezzine e casa a Milano dove è anche direttore della comunicazione per l'Università Cattolica. Per anni, aveva accarezzato l'idea di un curioso romanzo che finalmente nel 2021 ha visto la luce per l'editore Marsilio con il titolo "Poco a me stesso". E si presenta come un raffinato esercizio di stile.
La storia comincia dall'arrivo a casa Beccaria di un singolare personaggio: il barone Aurélien de Cerclefleury, tardivo esponente del mesmerismo, pratica medica definita magnetismo animale dal suo ideatore, Franz Anton Mesmer, nazionalità tedesca ma molto attivo anche in Francia. Con non pochi seguaci nonostante l'opposizione della scienza ufficiale. E si sa come certe cose vadano ancora ai nostri giorni.

Giulia Beccaria viveva in un'ala della casa che fu del padre e divenuta di proprietà del fratellastro Giulio, tutto sommato «ben disposto verso quella sorella che aveva avuto fama di scapestrata, ma che il tempo aveva poi domata fino a trasformarla nella dama anziana e gentile dalla quale il barone di Cerclefleury era stato convocato».
«Fosse stata meno ribelle - scrive Zaccuri -, Giulia avrebbe potuto accasarsi con uno dei migliori partiti della città, ma non si può essere una Beccaria, né si può discendere dalla nobiltà di Spagna, senza nutrire in seno una smania di libertà più tenace d'ogni altro legame. Molto aveva amato (...). Aveva avuto un amante, lì in Milano, che quasi gli era stato marito, e più tardi, se solo si fosse persuasa, avrebbe potuto seguire a Parigi colui che, si mormorava, era stato il vero amore della sua vita e avrebbe saputo esserle anche compagno fedele. Aveva scelto per sé, invece, che è come dire che aveva scelto sé stessa, anche a costo di suscitare il dispetto e forse l'ira di quel padre che pure si dimostrava sommamente magnanimo nel difendere i derelitti. (...) A un certo punto, indispettito dall'ostinazione di quel nubilato, il marchese non aveva escluso un matrimonio di scarsa convenienza, purché matrimonio fosse. Si erano esaminati diversi candidati, compreso un nobilotto della Valsassina, di un paio d'anni più anziano del Beccaria medesimo. Vedovo, questo conte Manzoni avrebbe volentieri condotto la sposina in una delle sue tetre dimore (...) ma infine nulla era stato concluso».

Viveva ormai ritirata «e la rendita di cui la donna disponeva le consentiva di tenere con sé un piccolo equipaggio di servizio di un paio di cameriere mormoranti, una cuoca silenziosa (...) e, ciò che più importava, un contabile al quale era demandata per intero l'amministrazione di un patrimonio non sfarzoso e non disprezzabile. Era quest'uomo di fiducia sui cinquant'anni, ombroso all'apparenza e incline alla balbuzie». Si trattava appunto del predetto Evaristo Tirinnanzi: un "trovatello" che la marchesina Giulia, come altre nobili inclini a opere di beneficenza, aveva assunto per le virtù decantatele all'orfanotrofio in cui era cresciuto, dopo che ignoti l'ebbero lasciato sulla ruota degli esposti in un giorno del marzo 1785. Quando, secondo il nostro calendario, sarebbe anche nato "quell'altro" tipo che va sotto il nome di Alessandro Manzoni.

Era questo ambiente ad accogliere il barone, che ci appare fin da subito un po' sospetto, chiamato ad alleviare le sofferenze di Giulia e delle amiche nel corso di sedute da tenersi nel di lei salotto.

Non raccontiamo la trama o di certe conclusioni che pure si intuiscono durante la lettura o magari già intuite. Ci limitiamo al teatro fatto di poche scene: Palazzo Beccaria, naturalmente; la chiesa di San Fedele che ai manzoniani qualcosa pur dice; infine, il Bottonuto, la suburra milanese, il quartiere cancellato all'indomani della prima guerra mondiale, il quartiere dove il Tirinnanzi andava a soddisfare il vizio del gioco, perdendo a dadi una fortuna che il barone si ingegnava di fargli recuperare. E ci limitiamo ai personaggi: a quelli già citati si aggiungono nobildonne un po' svanite, un padre gesuita, un cavaliere in ristrettezze che punta all'eredità della marchesina, una giovane servetta maliziosa e un'altra più anziana e arcigna, un eccentrico lestofante circondato da sgherri e "donnine", un "messaggero" che di nome fa naturalmente Menico e che finisce inguaiato e pentito a pronunciare parole già sentite («Meglio avrei fatto a non mettermi nei tumulti»).

Tema ambizioso e forse non nuovo, considerato che la "questione del padre" torna spesso a proposito proprio del Manzoni e dei promessi sposi.

«Strada facendo - leggiamo ancora nella "giustificazione" -, mi sono persuaso che, se proprio volevo raccontare questa storia, non potevo fare altro che assoggettarmi allo stile e alle convenzioni di quei romanzi che Manzoni non volle scrivere e dai quali, nonostante tutto, noi lettori continuiamo a trarre impareggiabile diletto. L'enfasi di Balzac, gli stratagemmi di Dickens, gli incredibili colpi di scena di Dumas père sono mescolati in questi capitoli, che hanno come elemento unificante il ricorso a una lingua italiana intenzionalmente attardata su un versante settecentesco. Così, sono tentato di credere, sarebbe stata la nostra prosa se Manzoni non l'avesse riscattata dal rischio - sempre incombente - della verbosità»
Un altro contributo dunque si aggiunge a quelle mole di rivisitazioni che in poco meno di due secoli il Gran Romanzo è stato in grado di sollecitare.
Dario Cercek