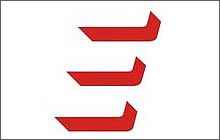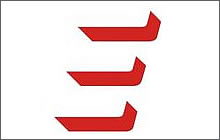SCAFFALE LECCHESE/48: Ignazio Cantù, prolifico e poco valorizzato 'educatore popolare'
Li chiamano poligrafi: scrittori prolifici che scorrazzano tra generi diversi. Figura un tempo diffusa, qualcuna immortale e la gran parte dimenticata, soprattutto in quell’Ottocento in cui non erano gli stimoli a mancare. In questa schiera si colloca Ignazio Cantù, il fratello minore di Cesare e che minore restò anche nella fama, trascurato pure dalla toponomastica e dall’arte lapidaria. Nacque nel 1810 a Brivio, vi rimase con i nonni fino al 1821, per poi seguire il fratello maggiore nelle peregrinazioni lombarde. Morì a Monza nel 1877, lasciando una corposa mole di pubblicazioni: libretti moraleggianti, saggi tra cui addirittura una Storia universale, un vocabolario d’Italiano, testi scolastici, novelle brianzole e una Storia della Brianza che pare sia stata apprezzata da Carlo Cattaneo. E l’inevitabile romanzo storico (“Annibale Perrone”) che, dopo la lezione manzoniana, pare fosse quasi cimento d’obbligo per ogni letterato milanese. Di cotanta produzione, quasi nulla sembra avere lasciato segno. Confermando dunque l’impressione di un talento dissipato nell’ambizione di voler scrivere troppo e di troppo. Così che, oggi, per le sue opere si registra una gran presenza sulle bancarelle antiquarie e una pressoché totale assenza di lettori.
Per i ceti popolari non era certo il migliore dei mondi quello che si ritrovavano ad abitare a metà del XIX secolo. E non soltanto perché si dovrebbe essere tutti fratelli, figli di un padre comune, mentre «sgraziatamente non è così: l’amor proprio usurpa spesso il posto della fraternità. Molti non si fanno scrupolo di distruggere la riputazione e l’onore altrui, purché torni a loro vantaggio (…) Periscano tutti purché noi ci guadagniamo. Eppure quanto è dolce vivere tra fratelli»: ciò è condizione eterna, tali lamentazioni corrono anche nel nostro stesso tempo e si persevera nel vivere senza scrupoli.
Non solo per questo, dunque. Quanto per la vita quotidiana stentata, drammatica, inumana, brutale: un trascinare i giorni sgobbando per una crosta di pane, a capo chino di fronte al mondo del quale si portava ogni male sulle spalle, nemmeno trattati come bestie perché una bestia vale più d’un uomo, umiliazioni costanti, fatica dura soltanto per sopravvivere e troppe osterie a portata di gomito, mariti ubriachi, figli e mogli malmenati («Oltre ai tormenti e alle privazioni, a tali sventurate era d’uopo adattarsi ai capricci ed alle assurdità di un ubbriaco e sopportarne coraggiosamente le asprezze e le tenerezze, forse più ributtanti»).
Occorrono libri, certo: «Migliorate le condizioni dei figli del popolo coll’aggiunta di qualche cosa di più che l’abbiccì e l’abbaco, ne verrebbe del meglio all’agricoltura e all’industria, e finirebbe col procurare una generale agiatezza e diminuire gli ostacoli alla moralità», ma nei villaggi troppo spesso mancano «libri opportuni, oltre all’abbecedario, all’ufficio e qualche altro libro di chiesa per sovrappiù molte volte in latino. E cosa costerebbe il metter buoni libri in mano al popolo?»).
E occorrono le scuole, naturalmente: che non siano il semplice affidare i fanciulli a un maestro «rubato alla vanga, al subbio o alla sega», malissimo pagato dal comune e costretto «a rifarsi sulle famiglie, mendicando legna, legumi, al patto mortificante di riceverli misti ai lamenti sul disagio dei tempi e sul peso d’aver figli», costretto ancora a dedicarsi ad altri mestieri (aiutare in chiesa, fabbricar canestri, tessere cappelli, mettersi a servizio per la fienagione o la vendemmia), eppure stentando sempre il pane quotidiano.
«L’autorità che gli era negata dalla persona – osservava Ignazio Cantù - gli veniva invece da argomenti più efficaci: dalla verga, dal nerbo, principalissimi ornamenti della sua scuola». Ciò era, nonostante qualche buona legge fosse pur stata promulgata. Ma aperte le scuole non si diede ai comuni «facoltà che di pagare una quasi limosina al povero maestro, il quale dopo aver corso il sentiero degli studii, imparato il metodo, sostenuti gli esami andava a vendere a vil mercato salute e polmoni».
I buoni maestri, le buone scuole pare non fossero poi una gran priorità per i governi (senza sottintesi ironici all’oggi, la situazione dell’epoca era davvero tragica): «Per ben reggere l’istruzione e farne un’opera nazionale, convien formar gli istruttori prima delle scuole, assicurar loro un decente sussidio e renderne l’officio oggetto di onesta ambizione. Con queste previdenze si migliorerà la condizione delle scuole elementari più che non faccia un esame presso la direzione o gli ispettorati. (…) Ricco paese com’è l’Italia, dove l’agricoltura, il commercio, l’industria forniscono ampi mezzi, perché sarà tollerato che il maestro de’ vostri figli debba apparir all’occhio degli scolari abbietto pel tradizionale avvilimento che colpisce il povero o lo abbassa agli ultimi gradini della scala sociale E a cariche di questa sorta vorrà aspirare chi appena appena si senta atto a qualche guadagno migliore? Salvatelo dal bisogno, provvedetelo di onesto sussidio, non lasciatelo più essere il servo del comune. Né il solo comune, ma anche lo stato pensi a questi maestri: tutti siamo cittadini e tutti abbiamo perciò diritto di essere istruiti, e l’istruzione è uno dei cardini per l’esistenza di un popolo: gridiamo forte che l’istruzione è un debito del governo e che ciascuno può pretendervi. (…) Quindi l’istruzione popolare non è un dono, ma un dovere sacro di chi tiene il regime de’ popoli. Mettete il maestro al riparo del bisogno: ed eccolo salvato dall’abbiettezza, dalla servitù, cavato dalla fitta degli ossequiosi, dotato, in una parola, di indipendenza, di dignità di fiducia, spinto a divenir sempre migliore, ad acquistarsi sempre nuove nozioni, avendo ne’ suoi doveri e ne’ suoi studi una bastevole fonte di guadagno. In tal modo la sua professione diverrà scopo d’onesta ambizione, e vi concorreranno anche molti che oggi applicano a professioni più lucrose».
Nello Scaffale si troverà spazio anche per qualcuno di questi lavori, ma qui vogliamo soffermarci su un aspetto particolare, vale a dire sul costante impegno a favore dell’istruzione popolare. Aspetto che meriterebbe seri approfondimenti in grado di rivalutarne, se non lo spessore letterario, quanto meno la passione civile.

Ignazio Cantù
Vero che il clima politico dell’epoca poneva interrogativi incalzanti agli intellettuali e sollecitava risposte. Andavano sorgendo le prime associazioni di mutuo soccorso che non erano mera assistenza, ponendosi tra gli altri anche l’obiettivo d’innalzare la cultura dei lavoratori con scuole serali o domenicali. Di questo movimento, Ignazio Cantù non fu personaggio di seconda fila: già nel 1840, dalla tipografia Lampato di Milano fece uscire a fascicoli una Enciclopedia popolare (“Collezioni di letture amene ed utili a ogni persona”).
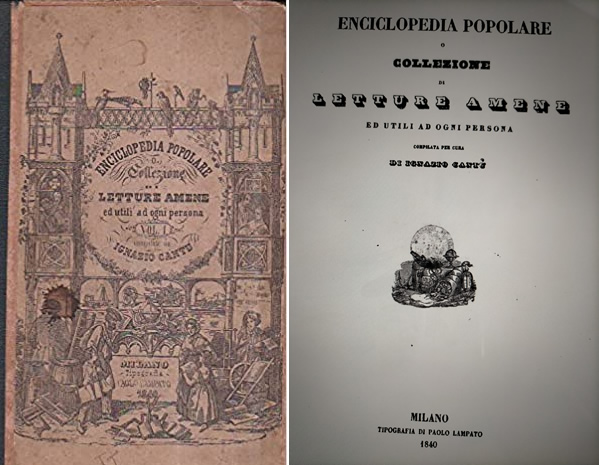
Era una miscellanea di notizie storiche, consigli pratici e domestici, biografie di personaggi famosi, racconti morali. Pare ricevesse qualche critica per un linguaggio definito non proprio popolare. E considerato il pubblico al quale si rivolgeva, non sarebbe pecca trascurabile. Ma il “nostro” non demorse.
Quella che poi sarebbe stata chiamata divulgazione era attività alla quale ormai si dedicavano sempre più spesso studiosi sensibili. Ne abbiamo già parlato, in questa rubrica, a proposito di Antonio Stoppani e del suo “Bel Paese” (QUI)Si ricorderà: il geologo lecchese aveva costruito il proprio libro come il racconto di una serie di serate in cui egli stesso vestiva i panni di uno zio docente che intratteneva i nipoti ai quali spiegare i misteri delle scienze. Anche il “nostro” Ignazio, nel 1861 (un quindicennio prima del “Bel Paese”, tanto per intenderci), pubblicò con l’editore Agnelli di Milano “La domenica di Germignano.
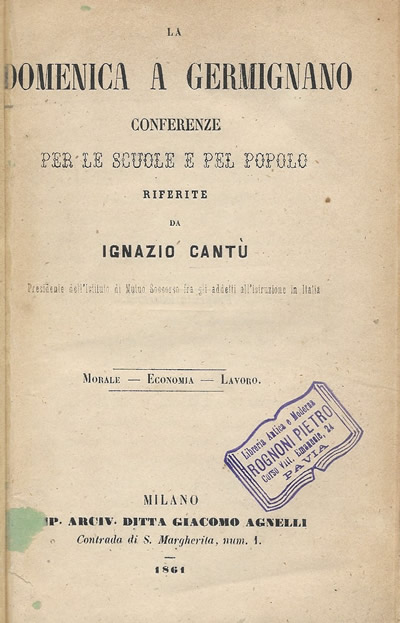
Conferenze per le scuole e pel popolo”, libro che pare rivesta una qual non trascurabile importanza all’interno di quella tradizione. Proprio introducendo una moderna edizione del “Bel Paese” (anno 2009, Aragno editore), Luca Clerici scriveva che l’opera di Ignazio Cantù «inaugura la letteratura divulgativa dell’Italia unita». Niente di meno. Chapeau, dunque.
Germignano è probabilmente luogo immaginario (in internet ci imbattiamo in una Cascina San Germignano nella Bergamasca, ma chissà), irreale anche per certi rapporti sociali idilliaci. Ci sono un parroco caritatevole e un proprietario sensibile alle sorti dei propri lavoranti: sono loro a istruire la piccola folla di contadini e operai che, la domenica sera, si raduna sul sagrato della chiesa. Sono lezioni e discussioni che trattano – così come le ha articolate Cantù - di morale, di igiene, di salute, di economia sociale, di diritti e doveri del cittadino (ruolo peraltro molto di là dal venire per i poveri e i nullatenenti), del governo della società, delle tasse, dell’industria manifatturiera, di fisica, di chimica agraria, del mutuo soccorso e del concetto di proprietà (la cui inviolabilità cominciava a essere messa in discussione). Per i ceti popolari non era certo il migliore dei mondi quello che si ritrovavano ad abitare a metà del XIX secolo. E non soltanto perché si dovrebbe essere tutti fratelli, figli di un padre comune, mentre «sgraziatamente non è così: l’amor proprio usurpa spesso il posto della fraternità. Molti non si fanno scrupolo di distruggere la riputazione e l’onore altrui, purché torni a loro vantaggio (…) Periscano tutti purché noi ci guadagniamo. Eppure quanto è dolce vivere tra fratelli»: ciò è condizione eterna, tali lamentazioni corrono anche nel nostro stesso tempo e si persevera nel vivere senza scrupoli.
Non solo per questo, dunque. Quanto per la vita quotidiana stentata, drammatica, inumana, brutale: un trascinare i giorni sgobbando per una crosta di pane, a capo chino di fronte al mondo del quale si portava ogni male sulle spalle, nemmeno trattati come bestie perché una bestia vale più d’un uomo, umiliazioni costanti, fatica dura soltanto per sopravvivere e troppe osterie a portata di gomito, mariti ubriachi, figli e mogli malmenati («Oltre ai tormenti e alle privazioni, a tali sventurate era d’uopo adattarsi ai capricci ed alle assurdità di un ubbriaco e sopportarne coraggiosamente le asprezze e le tenerezze, forse più ributtanti»).
Riecheggia in qualche modo (o è nostra suggestione?) la pedagogia popolare del Carlambrogio da Montevecchia, il personaggio ideato dal fratello Cesare nel libro del 1836 e che ebbe molta fortuna (QUI).
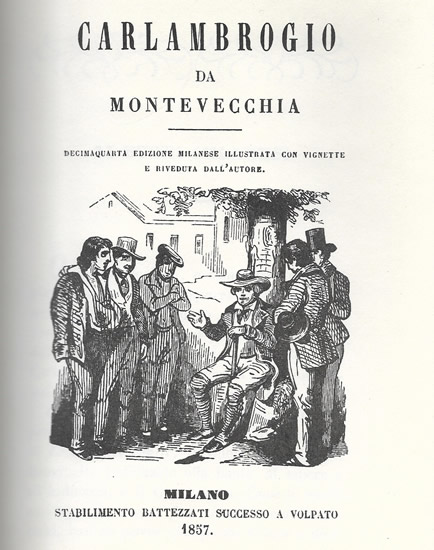
Occorrono libri, certo: «Migliorate le condizioni dei figli del popolo coll’aggiunta di qualche cosa di più che l’abbiccì e l’abbaco, ne verrebbe del meglio all’agricoltura e all’industria, e finirebbe col procurare una generale agiatezza e diminuire gli ostacoli alla moralità», ma nei villaggi troppo spesso mancano «libri opportuni, oltre all’abbecedario, all’ufficio e qualche altro libro di chiesa per sovrappiù molte volte in latino. E cosa costerebbe il metter buoni libri in mano al popolo?»).
E occorrono le scuole, naturalmente: che non siano il semplice affidare i fanciulli a un maestro «rubato alla vanga, al subbio o alla sega», malissimo pagato dal comune e costretto «a rifarsi sulle famiglie, mendicando legna, legumi, al patto mortificante di riceverli misti ai lamenti sul disagio dei tempi e sul peso d’aver figli», costretto ancora a dedicarsi ad altri mestieri (aiutare in chiesa, fabbricar canestri, tessere cappelli, mettersi a servizio per la fienagione o la vendemmia), eppure stentando sempre il pane quotidiano.
«L’autorità che gli era negata dalla persona – osservava Ignazio Cantù - gli veniva invece da argomenti più efficaci: dalla verga, dal nerbo, principalissimi ornamenti della sua scuola». Ciò era, nonostante qualche buona legge fosse pur stata promulgata. Ma aperte le scuole non si diede ai comuni «facoltà che di pagare una quasi limosina al povero maestro, il quale dopo aver corso il sentiero degli studii, imparato il metodo, sostenuti gli esami andava a vendere a vil mercato salute e polmoni».
I buoni maestri, le buone scuole pare non fossero poi una gran priorità per i governi (senza sottintesi ironici all’oggi, la situazione dell’epoca era davvero tragica): «Per ben reggere l’istruzione e farne un’opera nazionale, convien formar gli istruttori prima delle scuole, assicurar loro un decente sussidio e renderne l’officio oggetto di onesta ambizione. Con queste previdenze si migliorerà la condizione delle scuole elementari più che non faccia un esame presso la direzione o gli ispettorati. (…) Ricco paese com’è l’Italia, dove l’agricoltura, il commercio, l’industria forniscono ampi mezzi, perché sarà tollerato che il maestro de’ vostri figli debba apparir all’occhio degli scolari abbietto pel tradizionale avvilimento che colpisce il povero o lo abbassa agli ultimi gradini della scala sociale E a cariche di questa sorta vorrà aspirare chi appena appena si senta atto a qualche guadagno migliore? Salvatelo dal bisogno, provvedetelo di onesto sussidio, non lasciatelo più essere il servo del comune. Né il solo comune, ma anche lo stato pensi a questi maestri: tutti siamo cittadini e tutti abbiamo perciò diritto di essere istruiti, e l’istruzione è uno dei cardini per l’esistenza di un popolo: gridiamo forte che l’istruzione è un debito del governo e che ciascuno può pretendervi. (…) Quindi l’istruzione popolare non è un dono, ma un dovere sacro di chi tiene il regime de’ popoli. Mettete il maestro al riparo del bisogno: ed eccolo salvato dall’abbiettezza, dalla servitù, cavato dalla fitta degli ossequiosi, dotato, in una parola, di indipendenza, di dignità di fiducia, spinto a divenir sempre migliore, ad acquistarsi sempre nuove nozioni, avendo ne’ suoi doveri e ne’ suoi studi una bastevole fonte di guadagno. In tal modo la sua professione diverrà scopo d’onesta ambizione, e vi concorreranno anche molti che oggi applicano a professioni più lucrose».
E proprio per questo Ignazio nel 1857 aveva fondato e presiedette l’Istituto di mutuo soccorso tra gli addetti all’istruzione in Italia («il primo tentativo di dare un'organizzazione agli insegnanti» ci informa la Treccani).

E su questo tema, nel 1871 pubblicherà “Uno per tutti. Tutti per uno. Mutualità e cooperazione. Libro pel popolo” che è un trattato sulle associazioni che andavano formandosi e che in quel periodo erano a un bivio cruciale: limitarsi alle iniziative assistenziali o anche svolgere vera e propria attività politica, come spingevano la corrente mazziniana, i primi socialisti, gli anarchici? Per Cantù, risorgimentale ma non rivoluzionario e anzi ostile a ogni forma di rivolta, l’intromissione politica sarebbe stata un «errore pernicioso». Aggiungendo, per certi versi con indubbia lungimiranza, una messa in guardia dall’intervento dello stato, dal socialismo dittatoriale, dal comunismo che ci darebbe una società come quella di Sparta, dai sindacati che «anziché appellarsi al risparmio e alla dignità personale fanno appello allo sciopero e alla guerra sociale» con i lavoratori trasformati in semplici strumenti che non discutono ma obbediscono. Nel contempo, sull’altra barricata, buona parte della classe liberale al potere spazzerebbe via d’un botto l’intero movimento cooperativo in un’Italia che è tra gli ultimi Paesi rimasti a non garantire il diritto di associazione perché visto con sospetto: «Confondendo l’abuso con l’uso – scrive -, scambiando gli errori degli uomini con la natura delle istituzioni, non ristettero di trovar condannevoli gli sforzi che si fanno. Proclamate i trionfi del lavoro; proclamate la fratellanza essi vi accusano di socialista. Né vediamo in questo caso perché non dovrebbesi dar tinta di socialismo la stessa Genesi, che impone all’uomo l’obbligo del lavoro; e socialisti tutti i cristiani che si collegarono nel precetto del Nazareno: “amatevi a vicenda”».
Nel libro si spiegano le società di reciproca assistenza, le banche di credito artigiane, le casse di risparmio, le casse di ricovero per la vecchiaia, le scuole professionali. «Perché la previdenza – la conclusione - è il primo gradino della scala della civiltà. Il meglio dei progressi materiali deve essere preceduto dal meglio dei costumi, delle abitudini, delle idee. Più le masse avranno cultura e benessere meno saranno disposte ad arrischiare i propri beni». Macché rivoluzioni, dunque: la società va migliorata «con l’intelligenza, la virtù, la giustizia e la libertà».Pagine di storia sociale, prima che letteratura. È quanto ci ha lasciato Ignazio Cantù, la cui condanna è stata quella di non scegliere una strada definitiva, continuando a volerne percorrere diverse e non arrivando così da nessuna parte. Eppure, ci sarebbero passi meritevoli.
Dario Cercek