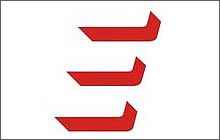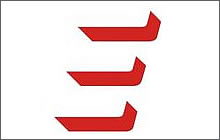In viaggio a tempo indeterminato/413: Quito è bella, anche se ci hanno rubato il portafoglio
"Il centro storico di Quito, la capitale dell'Ecuador, è stato il primo al mondo ad essere iscritto nella lista dei patrimoni dell'Unesco".
Lo leggo su una targa in marmo affissa fuori dalla cattedrale metropolitana.
Il mio primo pensiero?
Davvero Quito prima di Roma? O Parigi?
Mi giro verso la piazza.
Ci sono i signori che lucidano le scarpe a clienti dall'eleganza fuori dal tempo.
Ci sono i venditori di gelati che agitano il campanello per attirare bambini sognanti.
Le guardie impettite che vigilano annoiate il palazzo della presidenza.
Un via vai di turisti che si affollano sotto i bianchi portici appena le nuvole decidono che è tempo di annaffiare un po' questi umani rumorosi.
E se alzo lo sguardo, la bandiera sventola noncurante di tutto quello che succede, volenterosa solo di mostrare i suoi colori sgargianti e quel condor con le ali aperte che veglia sull'intero Paese.
A un bambino cade una pallina di gelato.
Un cane si avvicina per leccarla.
Osservo meglio i palazzi bianchi, le crepe lasciate dal tempo, il vulcano che fa capolino all'orizzonte.
Quito è bella, di quella bellezza decadente e fuori da ogni moda. Un po' dannata e un po' familiare.
Mi ricorda quei vecchi armadi che non si aprono da anni. Hanno quell'odore di naftalina che evoca subito il passato e dentro custodiscono sapientemente abiti eleganti tremendamente fuori moda.
Ci sono un'infinità di chiese nel centro di Quito, le guglie fanno il solletico alle facciate barocche. I canti delle messe escono dai portoni intagliati e si mescolano alle voci degli artisti di strada.
Si fa una fatica a Quito, ogni passo pesa il triplo a quasi 3000 metri di altitudine.

Una città così nasconde parecchi segreti e lati oscuri in cui anche noi siamo stati trascinati contro la nostra volontà.
C'è una leggenda famosissima a Quito che è emblematica.
Cantuña era un abile artigiano indigeno, vissuto nel periodo coloniale, noto per la sua intelligenza e per la sua grande abilità nel lavorare la pietra. I frati francescani decisero di affidargli un compito: completare la costruzione dell’atrio del Convento di San Francisco in pochissimi giorni.
L’impresa era praticamente impossibile.
Disperato e temendo di essere punito per il ritardo, Cantuña invocò il diavolo. Il demonio apparve e gli propose un accordo. Tutti i lavori sarebbero stati completati in una sola notte, ma in cambio lui avrebbe perso la sua anima. Catuña inizialmente penso di mandare al diavolo il diavolo stesso, ma non avendo alternative, si trovò costretto ad accettare il patto.
Quella notte, secondo la leggenda, orde di demoni iniziarono a lavorare freneticamente, trasportando e posizionando enormi pietre con una velocità sovrumana. All’alba, l’atrio era quasi completato.
Ma Catuña, che deve essere stato l'ispiratore del detto "ne sa una più del diavolo", aveva un asso nella manica.
Prima dell’inizio dei lavori, incise su una delle pietre necessarie per la costruzione una frase sacra di invocazione a Dio. Questo consacrava la pietra, rendendolo intoccabile dai demoni.
Così quando il diavolo tornò per reclamare l’anima promessa, Cantuña indicò l’atrio e fece notare che mancava ancora una pietra. Il lavoro non era stato completato al cento per cento, quindi il patto non era valido. Furioso, il diavolo sparì tra fiamme e urla, lasciando Cantuña libero e salvo.
Catuña rappresenta un po' il supereroe della porta accanto ma è anche il simbolo della resistenza e dell’ingegno del popolo indigeno, capace di sopravvivere all’oppressione coloniale usando intelligenza e astuzia.
E questa resilienza a Quito la si vede ancora. È nelle signore che vendono erbe medicinali nelle strade di fronte alle farmacie.
È nelle catene statunitensi di cibo spazzatura relegate a uno specifico quartiere della città, mentre nel centro storico il palato si delizia con cucina ecuadoriana.
È nelle signore con le bluse floreali, le gonne di lana e le lunghissime trecce nere.
Quito protegge la sua anima e trova un modo furbo di resistere anche ai tranelli del diavolo.
Ma arriviamo al lato oscuro. Quel vortice che ci ha trascinati.
A Quito ci hanno rubato il portafoglio.
Non esistono modi diversi di dirlo, quindi meglio essere diretti. La parte peggiore è che avevamo appena prelevato dall'atm, quindi carta e contanti sono si sono volatilizzati dalla tasca come per magia.
Paolo li aveva messi come sempre nella tasca bassa dei suoi pantaloncini, ma era al telefono con sua sorella in quel momento e le strade di Quito erano piene di gente intenta a festeggiare il quattrocentonovantunesimo compleanno della città.
Poteva succedere ovunque nel mondo, quindi Quito di per sé non ha colpe.
E noi, purtroppo, non avevamo il colpo di genio finale per fregare il "diavolo" di turno.
Non abbiamo perso l'anima ma di certo non possiamo dire di averla presa bene, soprattutto le prime ore dopo il fattaccio.
Sono i momenti del "se solo avessi..." quelli peggiori. Gli insulti alla fine si possono catalogare come "attività di sfogo creativo", ma il dubbio che avresti potuto fare qualcosa di diverso, diventa la goccia che cade incessantemente da un lavandino che perde quando sei a letto, è notte e non hai voglia di alzarti a fare pipì.

Quito è bella, di quella bellezza decadente e fuori da ogni moda. Un po' dannata e un po' familiare.
Ce la ricorderemo per sempre così.
Come il posto che ci ha preso il portafoglio ma ci ha lasciato la voglia di immergerci in quella vitalità senza freni che porta un'intera città a festeggiare anche un compleanno che non è un'occasione speciale.
Quito ci ha fatto andare oltre la dannazione, si è presa un pegno in cambio della possibilità di immergerci nella sua meraviglia.
Lo leggo su una targa in marmo affissa fuori dalla cattedrale metropolitana.
Il mio primo pensiero?
Davvero Quito prima di Roma? O Parigi?
Mi giro verso la piazza.
Ci sono i signori che lucidano le scarpe a clienti dall'eleganza fuori dal tempo.
Ci sono i venditori di gelati che agitano il campanello per attirare bambini sognanti.
Le guardie impettite che vigilano annoiate il palazzo della presidenza.
Un via vai di turisti che si affollano sotto i bianchi portici appena le nuvole decidono che è tempo di annaffiare un po' questi umani rumorosi.
E se alzo lo sguardo, la bandiera sventola noncurante di tutto quello che succede, volenterosa solo di mostrare i suoi colori sgargianti e quel condor con le ali aperte che veglia sull'intero Paese.
A un bambino cade una pallina di gelato.
Un cane si avvicina per leccarla.
Osservo meglio i palazzi bianchi, le crepe lasciate dal tempo, il vulcano che fa capolino all'orizzonte.
Quito è bella, di quella bellezza decadente e fuori da ogni moda. Un po' dannata e un po' familiare.
Mi ricorda quei vecchi armadi che non si aprono da anni. Hanno quell'odore di naftalina che evoca subito il passato e dentro custodiscono sapientemente abiti eleganti tremendamente fuori moda.
Ci sono un'infinità di chiese nel centro di Quito, le guglie fanno il solletico alle facciate barocche. I canti delle messe escono dai portoni intagliati e si mescolano alle voci degli artisti di strada.
Si fa una fatica a Quito, ogni passo pesa il triplo a quasi 3000 metri di altitudine.

Una città così nasconde parecchi segreti e lati oscuri in cui anche noi siamo stati trascinati contro la nostra volontà.
C'è una leggenda famosissima a Quito che è emblematica.
Cantuña era un abile artigiano indigeno, vissuto nel periodo coloniale, noto per la sua intelligenza e per la sua grande abilità nel lavorare la pietra. I frati francescani decisero di affidargli un compito: completare la costruzione dell’atrio del Convento di San Francisco in pochissimi giorni.
L’impresa era praticamente impossibile.
Disperato e temendo di essere punito per il ritardo, Cantuña invocò il diavolo. Il demonio apparve e gli propose un accordo. Tutti i lavori sarebbero stati completati in una sola notte, ma in cambio lui avrebbe perso la sua anima. Catuña inizialmente penso di mandare al diavolo il diavolo stesso, ma non avendo alternative, si trovò costretto ad accettare il patto.
Quella notte, secondo la leggenda, orde di demoni iniziarono a lavorare freneticamente, trasportando e posizionando enormi pietre con una velocità sovrumana. All’alba, l’atrio era quasi completato.
Ma Catuña, che deve essere stato l'ispiratore del detto "ne sa una più del diavolo", aveva un asso nella manica.
Prima dell’inizio dei lavori, incise su una delle pietre necessarie per la costruzione una frase sacra di invocazione a Dio. Questo consacrava la pietra, rendendolo intoccabile dai demoni.
Così quando il diavolo tornò per reclamare l’anima promessa, Cantuña indicò l’atrio e fece notare che mancava ancora una pietra. Il lavoro non era stato completato al cento per cento, quindi il patto non era valido. Furioso, il diavolo sparì tra fiamme e urla, lasciando Cantuña libero e salvo.
Catuña rappresenta un po' il supereroe della porta accanto ma è anche il simbolo della resistenza e dell’ingegno del popolo indigeno, capace di sopravvivere all’oppressione coloniale usando intelligenza e astuzia.
E questa resilienza a Quito la si vede ancora. È nelle signore che vendono erbe medicinali nelle strade di fronte alle farmacie.
È nelle catene statunitensi di cibo spazzatura relegate a uno specifico quartiere della città, mentre nel centro storico il palato si delizia con cucina ecuadoriana.
È nelle signore con le bluse floreali, le gonne di lana e le lunghissime trecce nere.
Quito protegge la sua anima e trova un modo furbo di resistere anche ai tranelli del diavolo.
Ma arriviamo al lato oscuro. Quel vortice che ci ha trascinati.
A Quito ci hanno rubato il portafoglio.
Non esistono modi diversi di dirlo, quindi meglio essere diretti. La parte peggiore è che avevamo appena prelevato dall'atm, quindi carta e contanti sono si sono volatilizzati dalla tasca come per magia.
Paolo li aveva messi come sempre nella tasca bassa dei suoi pantaloncini, ma era al telefono con sua sorella in quel momento e le strade di Quito erano piene di gente intenta a festeggiare il quattrocentonovantunesimo compleanno della città.
Poteva succedere ovunque nel mondo, quindi Quito di per sé non ha colpe.
E noi, purtroppo, non avevamo il colpo di genio finale per fregare il "diavolo" di turno.
Non abbiamo perso l'anima ma di certo non possiamo dire di averla presa bene, soprattutto le prime ore dopo il fattaccio.
Sono i momenti del "se solo avessi..." quelli peggiori. Gli insulti alla fine si possono catalogare come "attività di sfogo creativo", ma il dubbio che avresti potuto fare qualcosa di diverso, diventa la goccia che cade incessantemente da un lavandino che perde quando sei a letto, è notte e non hai voglia di alzarti a fare pipì.

Quito è bella, di quella bellezza decadente e fuori da ogni moda. Un po' dannata e un po' familiare.
Ce la ricorderemo per sempre così.
Come il posto che ci ha preso il portafoglio ma ci ha lasciato la voglia di immergerci in quella vitalità senza freni che porta un'intera città a festeggiare anche un compleanno che non è un'occasione speciale.
Quito ci ha fatto andare oltre la dannazione, si è presa un pegno in cambio della possibilità di immergerci nella sua meraviglia.
Angela (e Paolo)