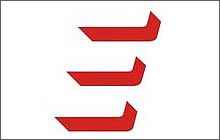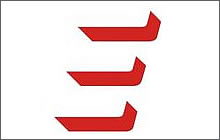ASST Lecco, lotta alle malattie del fegato: le nuove frontiere farmacologiche, dall'epatite Delta al tumore in fase avanzata
La prima paziente inizierà il trattamento proprio in questi giorni. Bulevirtide, il primo farmaco approvato contro l’Epatite Delta, quasi mezzo secolo dopo la sua scoperta, è ora in uso anche a Lecco, presso l’Unità operativa semplice di Epatologia dell’ASST, che ha nel dottor Pietro Pozzoni il proprio vertice – affiancato dai colleghi Alessia Riva e Paolo Villa -, articolazione dell’Unità operativa complessa di Medicina Generale diretta dal dottor Marco Soncini. Dal giugno scorso, poi, la struttura, sempre in tema di farmaci innovativi nella lotta alle patologie epatiche, ha introdotto l’immunoterapia, ultima (efficace) frontiera nel trattamento del tumore del fegato in fase avanzata. Già una dozzina i pazienti in cura. Ma andiamo con ordine.

Dottor Pozzoni, ci ricorda cos’è l’Epatite Delta e perché é così “pericolosa”?
L’epatite Delta è una malattia che interessa una quota di pazienti già affetti anche da epatite B. Il virus dell’epatite Delta (HDV) richiede infatti la presenza di quello dell’epatite B (HBV) per riuscire a replicarsi, essere in grado di infettare le cellule del fegato e causare in ultimo malattia epatica. L’infezione da HDV causa la più grave forma di epatite virale cronica, con tassi di progressione verso cirrosi ed epatocarcinoma (HCC) notevolmente maggiori rispetto alla monoinfezione da HBV e all’infezione da virus dell’epatite C.
Si tratta di una malattia rara?
Per quanto l’epatite Delta sia una malattia non comune, da quando si è cominciato a cercarla sistematicamente nei pazienti affetti da epatite B si è visto che non è neanche così rara. In Italia si stima che circa il 5% dei pazienti con epatite B abbiano anche una epatite Delta, dati che si traducono in una stima numerica di 10.000 pazienti circa. Percentuali maggiori si registrano in altre regioni del mondo, come l’est Europa o il subcontinente indiano, dove la malattia è endemica.
 Veniamo al trattamento. Come si cura?
Veniamo al trattamento. Come si cura?
Dalla scoperta di HDV, avvenuta nel 1977, l’epatite Delta è stata di fatto una malattia “orfana” di trattamento. Per molti anni è stato utilizzato l’interferone, farmaco non dotato di una azione antivirale diretta verso HDV ma di una azione di modulazione del sistema immunitario. Tale trattamento non è però stato mai approvato per l’uso nell’epatite Delta dalle autorità regolatorie,trattandosi pertanto di una cura “non ufficiale” e comunque con una efficacia relativamente limitata. Solo il 25% dei pazienti che rispondevano al trattamento con interferone (una terapia della durata di un anno, non priva di significativi effetti collaterali), mostrando una riduzione delle transaminasi o dei livelli di HDV nel sangue, mantenevano la risposta già a soli 6 mesi dalla fine del ciclo.
Nuove speranze per i pazienti affetti da questa grave forma di epatite virale sono portate dall’avvento della Bulevirtide, primo farmaco con un’azione diretta contro HDV, al quale impedisce l’ingresso all’interno dell’epatocita. Si tratta di un farmaco che deve essere assunto quotidianamente, somministrato per via sottocutanea. In Italia, la sua approvazione da parte di AIFA è avvenuta nei primi mesi del 2023 e dopo i passaggi burocratici del caso da pochi giorni è finalmente disponibile – anche nella Epatologia di Lecco – per tutti i pazienti affetti da epatite Delta, alla sola condizione che non abbiano già sviluppato una cirrosi avanzata.
Funziona?
 Come lo affrontate?
Come lo affrontate?
Si tratta di un tumore che nella maggior parte dei casi si sviluppa in pazienti già affetti da altre malattie di fegato, in molti casi già con una cirrosi epatica, con tutte le problematiche cliniche di malfunzionamento del fegato correlate a tale condizione, pertanto la gestione di tali tumori presuppone in qualunque centro ospedaliero di livello l’intervento di una equipe multidisciplinare di specialisti, che vede sempre l’epatologo in prima fila. L’epatologo diventa poi l’unico attore nei casi di tumore in fase più avanzata, quando le dimensioni o la localizzazione della malattia non consentono il ricorso a terapie chirurgiche o radiointerventistiche. In questi casi interviene la terapia farmacologica (“sistemica”) del carcinoma epatocellulare. I primi passi di questa terapia risalgono a circa 15 anni fa con il Sorafenib, rimasto fino a tempi recenti l’unica arma farmacologica a disposizione per questi pazienti. Negli ultimi anni sono comparsi sulla scena altri farmaci della stessa famiglia (cosiddetti “inibitori delle tirosin chinasi”): Lenvatinib (in alternativa al Sorafenib come trattamento di prima linea), Regorafenib e Cabozantinib (in seconda e terza linea dopo Sorafenib). Tutti questi farmaci, pur portando ad un incremento della sopravvivenza dei pazienti affetti da HCC avanzato, non hanno tuttavia fornito risultati clinici particolarmente soddisfacenti, spesso anche a fronte di effetti collaterali molto disturbanti per i pazienti. La vera svolta nel trattamento farmacologico dei pazienti con HCC avanzato è avvenuta tuttavia nell’ultimo anno con l’arrivo della cosiddetta immunoterapia.

Di cosa si tratta?
Di una nuova categoria di farmaci antitumorali che, con una modalità del tutto inedita rispetto al passato, non aggrediscono direttamente le cellule tumorali ma bloccano la loro capacità di nascondersi al nostro sistema immunitario, i soldati naturali del nostro organismo, che in questo modo riconoscono le cellule tumorali come “intruse” e provvedono alla loro distruzione. Atezolizumab e Bevacizumab – questo il nome dei due farmaci somministrati in associazione mediante infusioni endovenose praticate ogni 3 settimane nel day hospital dell’epatologia di Lecco – oltre ad essere ben tollerati dai pazienti hanno dimostrato una efficacia mai vista prima nel trattamento dei pazienti affetti da HCC avanzato, la cui sopravvivenza viene aumentata di oltre il 40% rispetto al “vecchio” Sorafenib. L’avvento della combinazione Atezolizumab-Bevacizumab rappresenta quindi una pietra miliare nell’ambito dell’epato-oncologia, un grande passo avanti che non solo amplia l’orizzonte terapeutico del paziente affetto da epatocarcinoma, ma ci consente anche una sempre maggiore personalizzazione della terapia, a vantaggio del paziente stesso.
Che, concretamente, riesce a veder allungata la propria prospettiva di vita?
Proprio così.

Il responsabile dell’Epatologia dell’ASST di Lecco, dottor Pietro Pozzoni
Dottor Pozzoni, ci ricorda cos’è l’Epatite Delta e perché é così “pericolosa”?
L’epatite Delta è una malattia che interessa una quota di pazienti già affetti anche da epatite B. Il virus dell’epatite Delta (HDV) richiede infatti la presenza di quello dell’epatite B (HBV) per riuscire a replicarsi, essere in grado di infettare le cellule del fegato e causare in ultimo malattia epatica. L’infezione da HDV causa la più grave forma di epatite virale cronica, con tassi di progressione verso cirrosi ed epatocarcinoma (HCC) notevolmente maggiori rispetto alla monoinfezione da HBV e all’infezione da virus dell’epatite C.
Si tratta di una malattia rara?
Per quanto l’epatite Delta sia una malattia non comune, da quando si è cominciato a cercarla sistematicamente nei pazienti affetti da epatite B si è visto che non è neanche così rara. In Italia si stima che circa il 5% dei pazienti con epatite B abbiano anche una epatite Delta, dati che si traducono in una stima numerica di 10.000 pazienti circa. Percentuali maggiori si registrano in altre regioni del mondo, come l’est Europa o il subcontinente indiano, dove la malattia è endemica.

Dalla scoperta di HDV, avvenuta nel 1977, l’epatite Delta è stata di fatto una malattia “orfana” di trattamento. Per molti anni è stato utilizzato l’interferone, farmaco non dotato di una azione antivirale diretta verso HDV ma di una azione di modulazione del sistema immunitario. Tale trattamento non è però stato mai approvato per l’uso nell’epatite Delta dalle autorità regolatorie,trattandosi pertanto di una cura “non ufficiale” e comunque con una efficacia relativamente limitata. Solo il 25% dei pazienti che rispondevano al trattamento con interferone (una terapia della durata di un anno, non priva di significativi effetti collaterali), mostrando una riduzione delle transaminasi o dei livelli di HDV nel sangue, mantenevano la risposta già a soli 6 mesi dalla fine del ciclo.
Nuove speranze per i pazienti affetti da questa grave forma di epatite virale sono portate dall’avvento della Bulevirtide, primo farmaco con un’azione diretta contro HDV, al quale impedisce l’ingresso all’interno dell’epatocita. Si tratta di un farmaco che deve essere assunto quotidianamente, somministrato per via sottocutanea. In Italia, la sua approvazione da parte di AIFA è avvenuta nei primi mesi del 2023 e dopo i passaggi burocratici del caso da pochi giorni è finalmente disponibile – anche nella Epatologia di Lecco – per tutti i pazienti affetti da epatite Delta, alla sola condizione che non abbiano già sviluppato una cirrosi avanzata.
Funziona?
I primi studi sull’efficacia di Bulevirtide sono molto incoraggianti. La somministrazione per 48 settimane normalizza le transaminasi in circa il 50% dei pazienti, riduce significativamente i livelli di HDV nel sangue in circa il 70% (fino a un completo azzeramento nel 20% dei casi) e induce una risposta combinata (normalizzazione delle transaminasi e riduzione significativa di viremia) nel 30-50%. Studi più lunghi condotti in Italia e in Francia hanno dimostrato che il prolungamento della terapia per 72 o 96 settimane determina un ulteriore progressivo incremento dei tassi di risposta virologica, biochimica e combinata, pertanto l’indicazione che viene data per il momento è di mantenere il trattamento a tempo indeterminato. Al momento non sono stati segnalati eventi avversi significativi attribuibili a tale trattamento.

Il carcinoma epatocellulare rappresenta invece una tra le più aggressive forme di tumore maligno ed è una delle principali cause di morti oncologiche in tutto il mondo.
Sì, già ora rappresenta il sesto tumore maligno al mondo come numero di casi diagnosticati e il terzo come numero di morti. Le prospettive per il futuro, poi, sono ancora più preoccupanti: da oggi al 2040 si stima che sia il numero di diagnosi sia il numero di morti per HCC potrebbe incrementare di oltre il 50%.
Si tratta di un tumore che nella maggior parte dei casi si sviluppa in pazienti già affetti da altre malattie di fegato, in molti casi già con una cirrosi epatica, con tutte le problematiche cliniche di malfunzionamento del fegato correlate a tale condizione, pertanto la gestione di tali tumori presuppone in qualunque centro ospedaliero di livello l’intervento di una equipe multidisciplinare di specialisti, che vede sempre l’epatologo in prima fila. L’epatologo diventa poi l’unico attore nei casi di tumore in fase più avanzata, quando le dimensioni o la localizzazione della malattia non consentono il ricorso a terapie chirurgiche o radiointerventistiche. In questi casi interviene la terapia farmacologica (“sistemica”) del carcinoma epatocellulare. I primi passi di questa terapia risalgono a circa 15 anni fa con il Sorafenib, rimasto fino a tempi recenti l’unica arma farmacologica a disposizione per questi pazienti. Negli ultimi anni sono comparsi sulla scena altri farmaci della stessa famiglia (cosiddetti “inibitori delle tirosin chinasi”): Lenvatinib (in alternativa al Sorafenib come trattamento di prima linea), Regorafenib e Cabozantinib (in seconda e terza linea dopo Sorafenib). Tutti questi farmaci, pur portando ad un incremento della sopravvivenza dei pazienti affetti da HCC avanzato, non hanno tuttavia fornito risultati clinici particolarmente soddisfacenti, spesso anche a fronte di effetti collaterali molto disturbanti per i pazienti. La vera svolta nel trattamento farmacologico dei pazienti con HCC avanzato è avvenuta tuttavia nell’ultimo anno con l’arrivo della cosiddetta immunoterapia.

Di cosa si tratta?
Di una nuova categoria di farmaci antitumorali che, con una modalità del tutto inedita rispetto al passato, non aggrediscono direttamente le cellule tumorali ma bloccano la loro capacità di nascondersi al nostro sistema immunitario, i soldati naturali del nostro organismo, che in questo modo riconoscono le cellule tumorali come “intruse” e provvedono alla loro distruzione. Atezolizumab e Bevacizumab – questo il nome dei due farmaci somministrati in associazione mediante infusioni endovenose praticate ogni 3 settimane nel day hospital dell’epatologia di Lecco – oltre ad essere ben tollerati dai pazienti hanno dimostrato una efficacia mai vista prima nel trattamento dei pazienti affetti da HCC avanzato, la cui sopravvivenza viene aumentata di oltre il 40% rispetto al “vecchio” Sorafenib. L’avvento della combinazione Atezolizumab-Bevacizumab rappresenta quindi una pietra miliare nell’ambito dell’epato-oncologia, un grande passo avanti che non solo amplia l’orizzonte terapeutico del paziente affetto da epatocarcinoma, ma ci consente anche una sempre maggiore personalizzazione della terapia, a vantaggio del paziente stesso.
Che, concretamente, riesce a veder allungata la propria prospettiva di vita?
Proprio così.